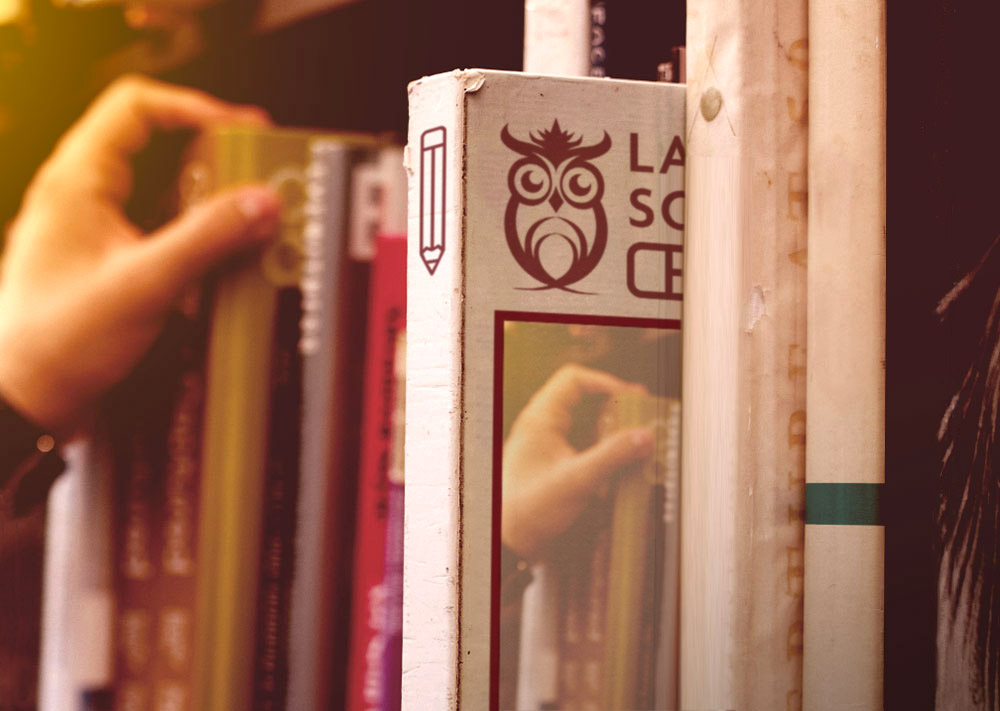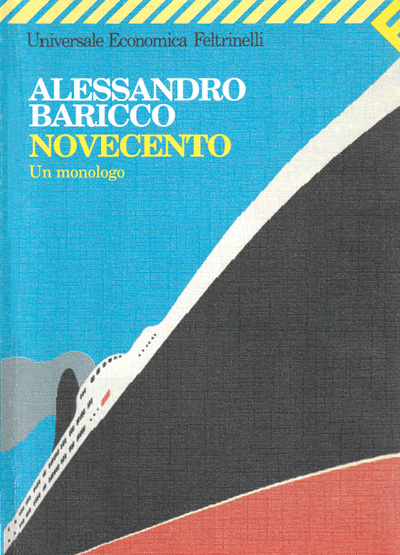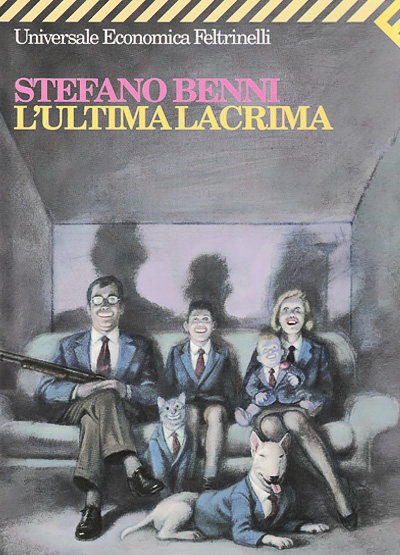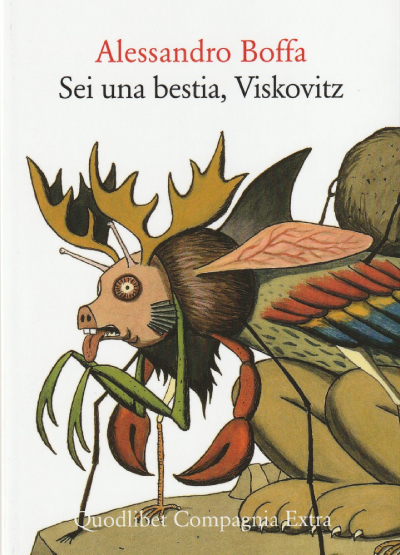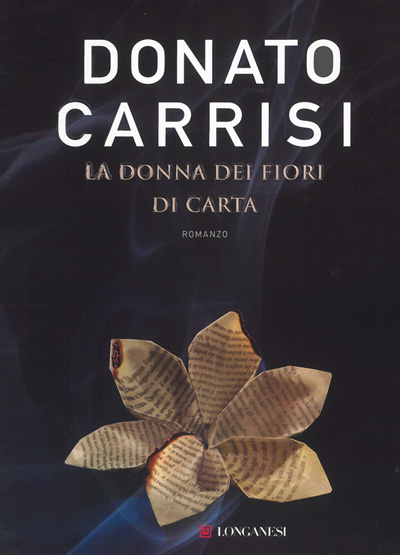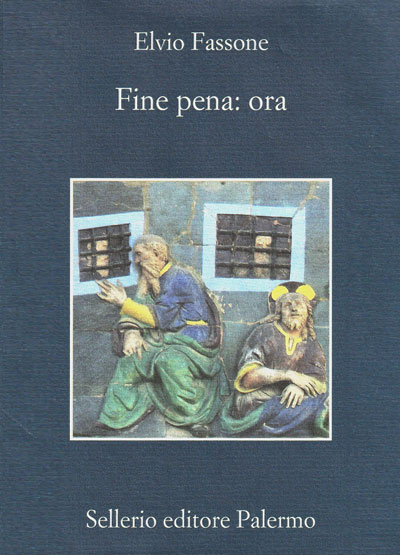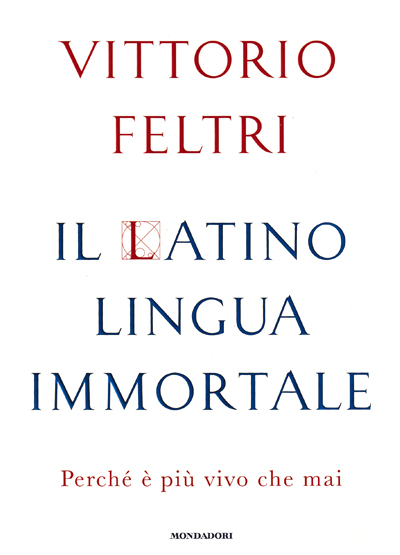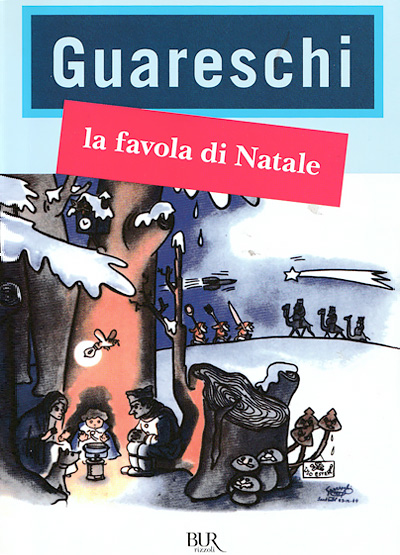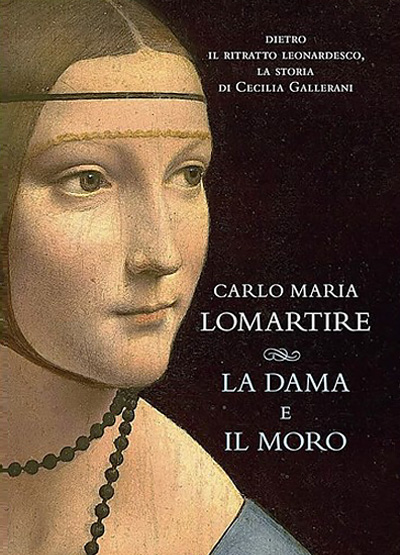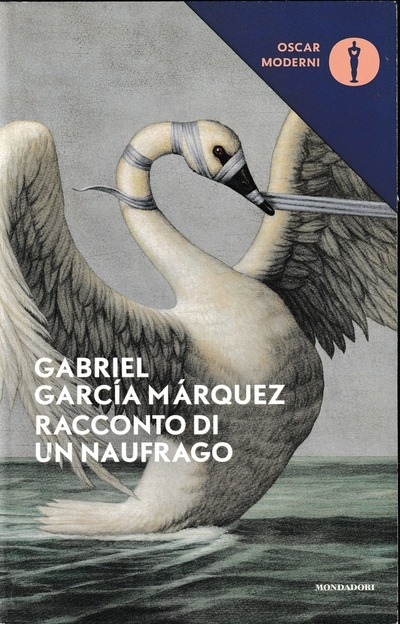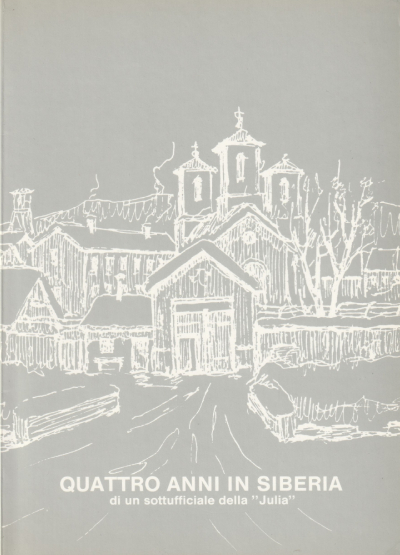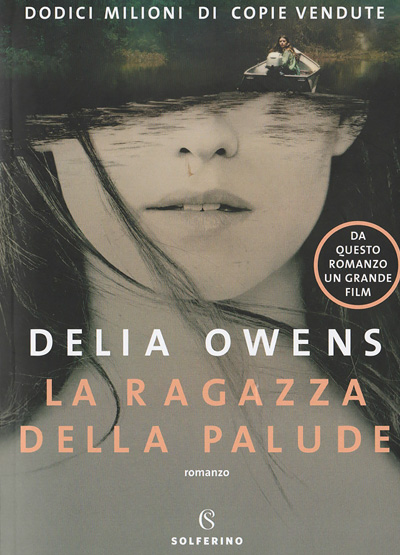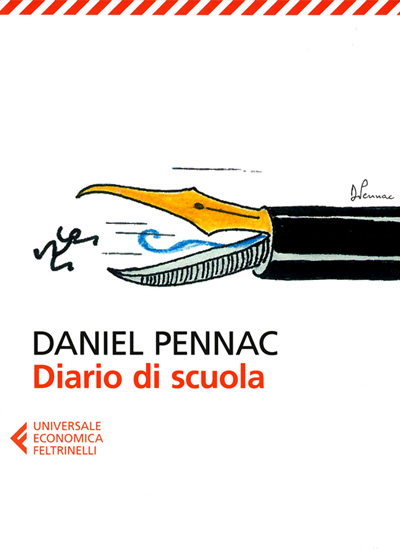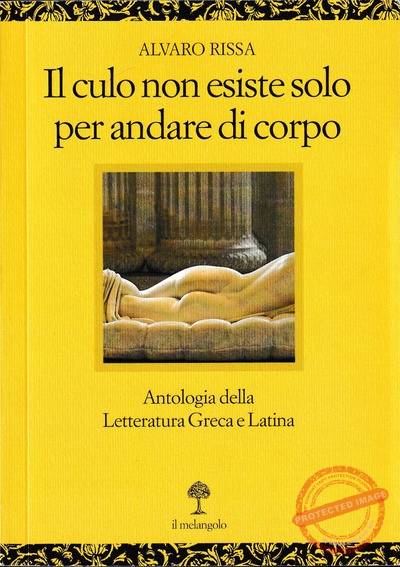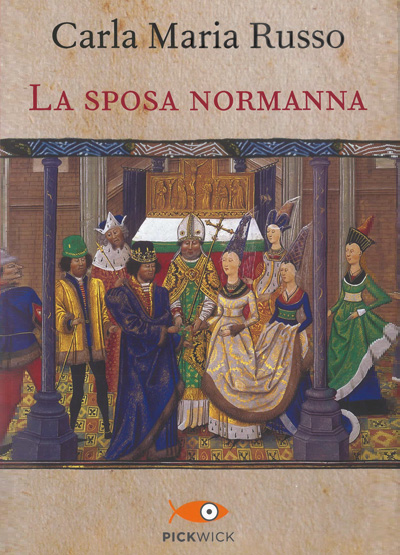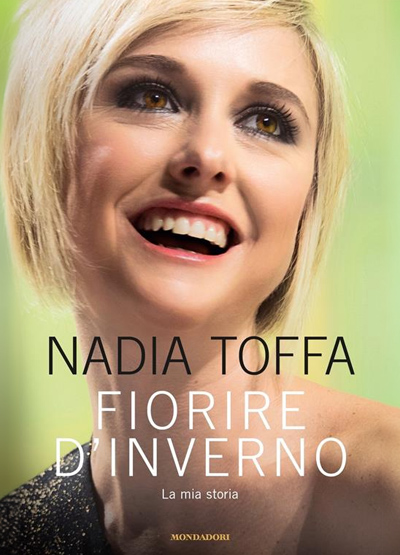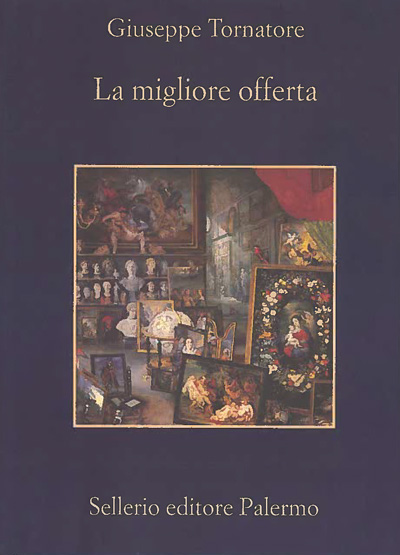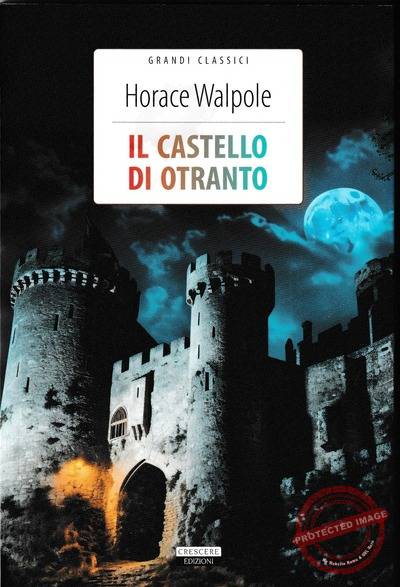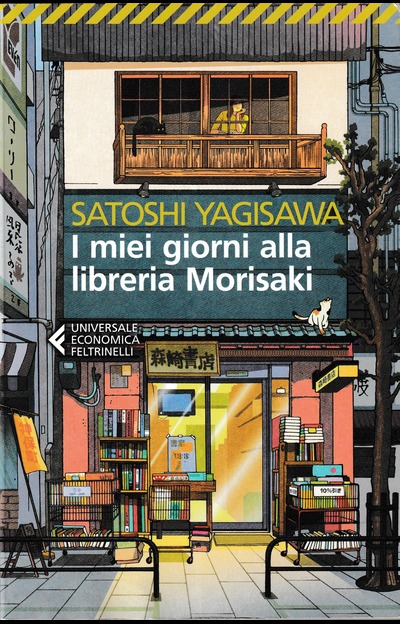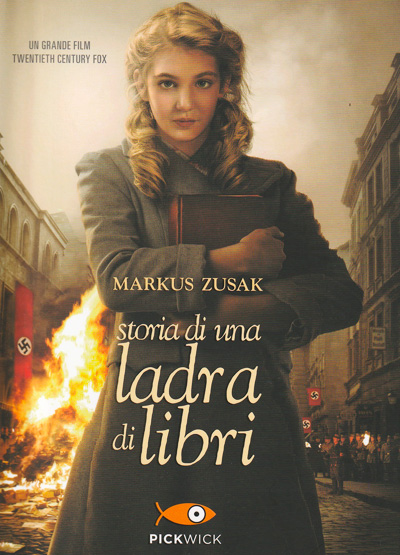Biblioteca
“Fondare biblioteche è come costruire ancora granai pubblici, ammassare riserve contro un inverno dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, vedo venire”.
Queste parole della scrittrice francese Marguerite Yourcenar rispecchiano perfettamente il mio pensiero. La Biblioteca della Sofisteria propone consigli di lettura per “ammassare riserve”, ma anche per condividere “il gioco più bello che l’umanità abbia inventato” (Wislawa Szymborska).
Consigli di lettura
Baricco, Alessandro
Novecento
Benni, Stefano
L’ultima lacrima
Boffa, Alessandro
Sei una bestia, Viskovitz
Carrisi, Donato
La donna dei fiori di carta
Fassone, Elvio
Fine pena: ora
Feltri, Vittorio
Il latino lingua immortale
Guareschi, Giovannino
La favola di Natale
Lomartire, Carlo Maria
La Dama e il Moro
Márquez, Gabriel García
Racconto di un naufrago
Micheloni, Firmino
Quattro anni in Siberia
Owens, Delia
La ragazza della palude
Pennac, Daniel
Diario di scuola
Rissa, Alvaro
Il culo non esiste solo per andare di corpo
Russo, Carla Maria
La sposa normanna
Toffa, Nadia
Fiorire d’inverno
Tornatore, Giuseppe
La migliore offerta
Walpole, Horace
Il castello di Otranto
Yagisawa, Satoshi
I miei giorni alla libreria Morisaki
Zusak, Markus
Storia di una ladra di libri
TITOLO: Novecento
AUTORE: Baricco, Alessandro
EDITORE: Feltrinelli
GENERE: Monologo teatrale
PAGINE: 62
A bordo del Virginian, negli anni tra le due guerre
È lo stesso autore, Alessandro Baricco, a presentarci, in una breve prefazione, questo piccolo capolavoro: Mi sembra piuttosto un testo che sta in bilico tra una vera messa in scena e un racconto da leggere ad alta voce. Non credo che ci sia un nome, per testi del genere. Comunque, poco importa. A me sembra una bella storia, che valeva la pena di raccontare. E mi piace pensare che qualcuno la leggerà (pag. 7).
Un piroscafo che solca l’Oceano. A bordo, accanto a ricchi passeggeri in crociera, ci sono dei disperati che lasciano il loro paese in cerca di fortuna. I giorni di viaggio scorrono lenti, finché accade… Succedeva sempre che a un certo punto uno alzava la testa… e la vedeva. È una cosa difficile da capire. Voglio dire… Ci stavamo in più di mille su quella nave, tra ricconi in viaggio, e emigranti, e gente strana, e noi… Eppure c’era sempre uno, uno solo, uno che per primo… la vedeva. Magari era lì che stava mangiando, o passeggiando, semplicemente, sul ponte… magari era lì che si stava aggiustando i pantaloni… alzava la testa un attimo, buttava un occhio verso il mare… e la vedeva. Allora si inchiodava, lì dov’era, gli partiva il cuore a mille, e, sempre, tutte le maledette volte, giuro, sempre, si girava verso di noi, verso la nave, verso tutti, e gridava (piano e lentamente): l’America (pag.11).
Il piroscafo percorre avanti e indietro la sua rotta, con il suo carico di uomini e con le loro storie. Tra di loro un pianista straordinario, che si esibisce per ricchi e poveri, ammaliandoli con la sua musica senza eguali… Lui diceva: “Non sei fregato veramente finché hai da parte una buona storia, e qualcuno a cui raccontarla”. Lui l’aveva una… buona storia. Lui era la sua buona storia. Pazzesca, a ben pensarci, ma bella (pag.17).
Già, perché Novecento, questo il suo nome, ha davvero una storia pazzesca alle spalle. Comincia quando un marinaio negro di Philadelphia (proprio così, negro, perché il monologo è stato scritto quando non erano le parole a fare paura, ma l’ignoranza e la superficialità di chi non le sa usare in modo opportuno, ragion per cui non era necessario limitarne o stigmatizzarne l’uso), un marinaio, dicevamo, lo trovò un mattino che erano già tutti scesi, a Boston, lo trovò in una scatola di cartone. Avrà avuto dieci giorni, non di più. Neanche piangeva, se ne stava silenzioso, con gli occhi aperti, in quello scatolone. L’avevano lasciato nella sala da ballo della prima classe. Sul pianoforte. Non aveva l’aria però di essere un neonato di prima classe. Quelle cose le facevano gli emigranti, di solito. Partorire di nascosto, da qualche parte del ponte, e poi lasciare lì i bambini. Mica per cattiveria. Era miseria, quella, miseria nera (pag. 18). Dovevano essersi fatti un ragionamento: se lo lasciamo sul pianoforte a coda, nella sala da ballo di prima classe, magari lo prende qualche riccone, e sarà felice tutta la vita. Era un buon piano. Funzionò a metà. Non diventò ricco, ma pianista sì. Il migliore, giuro, il migliore. (pag. 19)
E così Novecento diventa il figlio del piroscafo. Novecento non esisteva nemmeno, per il mondo: non c’era città, parrocchia, ospedale, galera, squadra di baseball che avesse scritto da qualche parte il suo nome. Non aveva patria, non aveva data di nascita, non aveva famiglia (pag. 22). Ma c’è. Ed è lì, a bordo del piroscafo, che è la sua casa e tutto il suo mondo…
È in questo mondo che il piccolo Novecento impara a fare due cose: suonare e ascoltare…. Già a otto anni suonava non so che diavolo di musica, ma piccola e… bella. Non c’era trucco, era proprio lui, a suonare, le sue mani, su quei tasti, dio sa come. E bisognava sentire cosa gli veniva fuori (pag. 24). E ancora: Sapeva ascoltare. E sapeva leggere. Non i libri, quelli son buoni tutti, sapeva leggere la gente. I segni che la gente si porta addosso: posti, rumori, odori, la loro terra, la loro storia…Tutta scritto, addosso. Lui leggeva, e con cura infinita, catalogava, sistemava, ordinava… Ogni giorno aggiungeva un piccolo pezzo a quella immensa mappa che stava disegnandosi nella testa, immensa, la mappa del mondo, del mondo intero, da un capo all’altro, città enormi e angoli di bar, lunghi fiumi, pozzanghere, aerei, leoni, una mappa meravigliosa. Ci viaggiava sopra da dio, poi, mentre le dita gli scivolavano sui tasti, accarezzando le curve di un ragtime (pag. 33).
È proprio grazie a queste due capacità che Novecento diventa un pianista meraviglioso. Ma il pianoforte non è solo musica: è anche un maestro di vita. Ora tu pensa: un pianoforte. I tasti iniziano. I tasti finiscono. Tu sai che sono 88, su questo nessuno può fregarti. Non sono infiniti, loro. Tu, sei infinito, e dentro quei tasti infinita è la musica che puoi fare. Loro sono 88. Tu sei infinito. Questo a me piace. Questo lo si può vivere (pag. 56).
Difficile contenere la commozione che accompagna la lettura delle pagine finali, che sublimano il senso di una vita dedicata alla musica, che lenisce i dolori e dona attimi intensi di felicità e – soprattutto – permette a Novecento di trovare un delicato e prezioso equilibrio tra finito e infinito, tra sogni e realtà. Di qui la sua struggente decisione finale, perché se quella tastiera è infinita, allora su quella tastiera non c’è musica che puoi suonare. Ti sei seduto su un seggiolino sbagliato: quello è il pianoforte su cui suona Dio (pag.56).
E se è difficile chiudere l’ultima pagina di un’esperienza di lettura breve, ma davvero intensa, ci si può consolare vedendo il film che è stato tratto da questo libro, La leggenda del pianista sull’Oceano, di Giuseppe Tornatore, in cui uno straordinario Tim Roth interpreta Novecento con una sensibilità e una grazia che trovano eguale solo nelle splendide melodie di un altro genio della musica, il maestro Ennio Morricone.
Ovunque… ieri, oggi, domani
La raccolta L’ultima lacrima, uscita nel 1994, riunisce ventisette racconti con cui Stefano Benni traccia l’impietoso ritratto di una realtà, quella contemporanea, sempre più invasa da comportamenti massificati e da mostruosità tecnologiche: così, nelle pagine di questo libro, ci si confronta con il potere della televisione, il consumismo, il conformismo, le difficoltà di chi viaggia, le problematiche economiche, l’abuso di potere, l’asservimento, il cinismo di chi pensa agli affari, le dure leggi di mercato, la forza dei sondaggi, il conflitto generazionale, la crescente disumanizzazione, la mancanza di senso critico, il desiderio di apparire… tematiche che sono affrontate con uno stile assolutamente unico.
Questi racconti, pur essendo spesso ambientati in luoghi di fantasia (persino nello spazio!) e in tempi assai lontani dal nostro (dalla Preistoria al futuro) in realtà non sono affatto distanti da noi: le invenzioni fantastiche di Benni affondano le loro radici nel nostro vissuto, nella nostra società, nel nostro ambiente, insomma nella nostra vita quotidiana, che l’autore trasfigura e ritrae, con evidente compiacimento, nelle pagine del suo libro. Così, per esempio, il conflitto generazionale, che è nato nella notte dei tempi, è affrontato con il racconto dell’amore adolescenziale tra Rex e Tyra, due tirannosauri in tutto e per tutto simili ai giovani d’oggi; le paventate conseguenze dello strapotere dei mezzi di comunicazione sono illustrate in un futuro in cui a scuola si studierà Storia della televisione e sarà punito chi non vede almeno sei ore di Tv al giorno:
– Allora, Zeffirini, cos’hai fatto invece di studiare?
– Ho letto.
La profe trasalì.
– Hai letto… cosa?
– Un libro di animali, signora maestra.
– Perché?
– Perché mi piacciono gli animali. Se vuole le posso elencare le distinzioni dei pesci in generi e classi, oppure le posso parlare dei delfini e delle grandi spedizioni oceanografiche…
– Non è nel programma, Zeffirini! Quando avrai fatto i tuoi compiti, potrai leggere tutti i libri che vuoi, ma prima no! (pag. 26).
L’effetto sorpresa, ottenuto introducendo in un contesto apparentemente normale una situazione anomala, che mette in atto una sorta di rovesciamento del reale, è appositamente ricercato da Benni per spronare il lettore a una riflessione consapevole su ciò che lo circonda. È quello che succede, per esempio, nel racconto intitolato Fratello Bancomat, in cui la macchina si comporta come una sorta di novello Robin Hood: essa, un meccanismo senz’anima che per la società è il simbolo della freddezza, dimostra, al contrario, di conoscere il valore – tutto umano – della solidarietà, mettendo in atto un rovesciamento del reale che giustifica e spiega il titolo del racconto… Questo meccanismo narrativo viene spesso portato al paradosso, come accade, per esempio, nel racconto intitolato Coincidenze, interamente costruito come un dialogo tra un uomo e una donna che si incontrano alla metà esatta di un ponte e che invece di riconoscersi come perfettamente complementari (da un lato del ponte avanzava un uomo con ombrello e cappotto. Dall’altro una donna con cappotto e ombrello, pag. 28) sfiorano l’amore senza neppure accorgersene, perché troppo impegnati a razionalizzare ciò che accade loro, derubricandolo a un’inspiegabile serie di coincidenze…
Questa modalità narrativa, che la critica definisce sfondamento del realismo, riguarda anche – e soprattutto – la straordinaria galleria di tipi umani che costituiscono i personaggi di questi racconti. Benni li presenta secondo i tradizionali canoni della narrativa (caratterizzazione fisica, psicologica, sociale…) ma vi aggiunge una serie di elementi assurdi e marcatamente comici che si affastellano uno sull’altro e che sono presentati al lettore come se fossero tratti del tutto normali: Erasmo Leproni, il protagonista di Erasmo, il venditore del cosmo, ha la straordinaria idea di vendere l’ombra agli abitanti del pianeta Bleton, sempre esposto al Sole, ma si dimentica di informarsi sull’aspetto dei bletoniani, difficilmente riconoscibili in un contesto di creature del cosmo dagli aspetti più strani; il puntualissimo viaggiatore de L’uomo puntuale si presenta come inesorabilmente segnato da questo stigma (Io sono, ahimè, puntuale dalla nascita. Sono nato al nono mese spaccato, piangevo per il latte ogni quattro ore, non sono mai arrivato in ritardo né all’asilo né a scuola, né in ufficio, o a un qualsiasi appuntamento, alzabandiera o funerale. Anche se mi sono accorto subito che la mia malattia era grave perché mi costringeva a corse, attese, delusioni, rabbie. Ero puntuale in un mondo di non puntuali, e non sono mai riuscito a smettere (pag. 61); c’è poi il signor Jacques “Jojo” Dubois di Arles (Francia) che ha una stranissima peculiarità: è l’unico pescatore al mondo che nei suoi racconti diminuisce lunghezza e peso delle prede. Ad esempio, il mese scorso, dopo aver pescato una carpa di sette chili, ha raccontato agli amici del bar di averne catturata una da quattro chili e mezzo. Il suo incredibile caso è attualmente all’esame della scienza medica (pag. 126) …
Accanto ai personaggi principali non mancano, poi, quelli che possono essere definiti delle macchiette, dei personaggi, cioè, dalla presenza limitata ma con una caratteristica molto marcata, che si esprime attraverso gesti, frasi, azioni che li rendono particolarmente incisivi (come il preside che rimprovera il povero Zeffirini –sempre lui! – perché a dodici anni non ha ancora un motorino e perché non ha adesivi, gadget e scritte sullo zaino di scuola, rivelandosi l’esatto contrario del ruolo istituzionale che riveste!).
Merita un cenno anche il linguaggio di Benni, reso particolarmente vivace e accattivante dalla sua capacità – affine a quella di un altro grande scrittore italiano, mai abbastanza conosciuto, Carlo Emilio Gadda – di stravolgere la sintassi, l’ortografia e il lessico. Benni si diverte a giocare con le parole mescolando neologismi, termini alti, vocaboli tecnici, esotismi, espressioni gergali o addirittura triviali, storpiando e deformando parole italiane e straniere, equivocando sui significati… Particolarmente felice, per esemplificare questa sua capacità, la prova di traduttore che egli fa dare al critico Zebél: “ed egli, incontrandola frale e rorida per la silvifora corsa, ebbe tema di vederla morsa dal rivelenar dei tubercoli, e accoronatole il tabarro ai labastri dorsali disse: “Cara, lei addiaccia…” Bello, vero? a cui l’autore del passo tradotto risponde: Bello? Da toccarsi le palle. Dieci metri sotto la pioggia e già me la ammazza di tisi. Io avevo scritto più o meno: Vedendola così sudata e temendo per la sua cagionevole salute le mise garbatamente la giacca sulle spalle e disse: signorina, ha freddo?” (pag. 164).
In questo gioco rientrano anche i nomi propri di luoghi e personaggi, che sono spesso parlanti, con un’evidente funzione simbolica o evocativa: è il caso del dottor Adattati, l’uomo tranquillo che plasma se stesso a seconda del direttore con cui ha a che fare: il dottor Adattati aveva infatti nella vita una sola idea chiara, irrinunciabile, trainante: non avere idee. In subordine (quindi) avere soltanto le idee dei suoi superiori. Come conseguenza teorica (riquindi), conoscere alla perfezione le loro idee. Come esito pratico (triquindi) adattare in tutto e per tutto il suo comportamento alle loro idee (pag.73).
Molto particolare e frequente è anche l’uso della figura retorica dell’iperbole, che consiste nel portare all’eccesso espressioni, concetti e azioni, espediente che produce un irresistibile effetto comico, come accade nella memorabile sfuriata del famoso tenore Manrico Del Pietro, soprannominato, non a caso, Re Capriccio, che tutti temono proprio per le sue scenate: Dopo un attimo, l’hotel fu investito dalla scenata del tenore. In ognuna delle duecentosei stanze la sua voce turbinò come una bufera, i camerieri cercarono rifugio negli ascensori, i clienti sotto i letti, i facchini dentro i bauli, nelle cucine rotolarono pentole e tegami, le maionesi impazzirono, i cuochi tremarono come gelatine. Tanta era l’onda d’urto di quella voce furibonda (pag. 89).
Il rovesciamento della realtà e gli artifici di parole strappano inevitabilmente ben più di una risata al lettore, che, come detto, viene però anche spinto a riflettere sulla realtà che sta dietro – o dentro o attorno – ai personaggi, proprio perché lo scopo principale della scrittura di Benni è far riflettere divertendo, come si addice a ogni bravo umorista: l’umorista, infatti, a differenza del comico, non vuole suscitare una risata, ma strappare un sorriso che spinga a scoprire il lato più sofferto e malinconico di ciò che lo ha suscitato (come spiega Pirandello nel suo famoso saggio intitolato L’umorismo).
E, a proposito di riflessioni, ci sono, in uno di questi racconti, delle parole davvero intense, quelle con cui uno dei personaggi, il libraio chiamato l’Alchimista, saluta i libri che sta vendendo: vorrei condividerle con voi, che, come me, amate i libri… si diceva che spiegasse ai libri quale viaggio stavano per intraprendere, che li consolasse della partenza, che li avvertisse degli usi e dei costumi del paese ove avrebbero vissuto, e degli eventuali pericoli. Al momento di consegnarli in posta, carezzava i pacchetti uno a uno, e formulava a bassa voce auguri di buon viaggio. Talvolta, tra gli sguardi comprensivi degli spedizionieri, si abbandonava al pianto. (pag. 33).
TITOLO: Sei una bestia, Viskovitz
AUTORE: Boffa, Alessandro
EDITORE: Quodlibet, per la collana Compagnia Extra
GENERE: Romanzo in racconti umoristici
PAGINE: 161
Dal Precambriano… ai giorni nostri
Il biologo Alessandro Boffa ha scritto questo romanzo umoristico, composto da venti brevi racconti (che ricordano le favole di Esopo, Fedro e La Fontaine), con il lessico, le competenze e le conoscenze scientifico – naturalistiche dello studioso, con la leggerezza e il cinismo dell’umorista, e con un’invidiabile capacità di narrare, che strizza l’occhio all’apologo e al noir, alla fiaba e alla leggenda, al western e alla satira…. Non meraviglia, dunque, che il suo lavoro abbia avuto uno straordinario successo, tanto da essere tradotto in una ventina di lingue e trasformato in uno spettacolo teatrale.
Il protagonista delle pagine di Boffa è un animale, Viskovitz, che subisce incredibili metamorfosi, trasformandosi in ogni racconto in un essere diverso, di cui assume caratteristiche, atteggiamenti e comportamenti per affrontare un ciclo vitale sempre identico, che prevede la nascita, la crescita, la riproduzione, la sopravvivenza e il tentativo di scongiurare la morte. Ecco dunque un Viskovitz lumaca ossessionata dal sesso (avendone ben due), pappagallo innamorato – e deluso -, ex cane antidroga ora buddista, microbo con il complesso d’inferiorità, ghiro che fa sogni erotici, scarabeo stercorario sempre in cerca di letame, spugna in balia delle correnti, scorpione serial killer, fringuello pieno di paranoie, squalo con un figlio che si sente in colpa per essere un carnivoro…
Accanto a Viskovitz ricorrono due presenze femminili, Lara (o Jana) e Ljuba. Lara (o Jana) rappresenta la compagna reale, spesso caratterizzata da limiti e difetti (Lara ghiro è la femmina più brutta e deprimente dell’intera comunità, la più tediosa e sciocca pag.12); Ljuba è invece la compagna ideale, la femmina bellissima e inarrivabile a cui si desidera affidare il proprio patrimonio genetico per produrre esemplari perfetti, perché è proprio questo il chiodo fisso di ogni Viskovitz del romanzo.
Ci sono poi gli amici – o nemici -, Petrovic, Zucotic e Lopez, che aiutano – od ostacolano – il narratore nelle sue diverse avventure, che avvincono e divertono il lettore non solo con le spiazzanti e fulminanti battute di cui sono ricche (cito come esempio – ma la scelta è davvero difficile! – il colloquio tra il piccolo della mantide e la mamma: “Com’era papà?” chiesi a mia madre. “Croccante, un po’ salato, ricco di fibre” (pag. 31) e il modo di consolarsi della spugna per le sue pene d’amore Il dramma di essere un vegetale era l’impossibilità di suicidarsi. Il vantaggio di essere una spugna era la possibilità di berci sopra – pag.144), ma anche con una capacità affabulatoria che incatena e che invita il lettore a passare subito alla nuova e sorprendente metamorfosi di Viskovitz.
Scelgo – sempre a fatica – una metamorfosi da proporvi, il Viskovitz camaleonte protagonista del racconto intitolato Chi ti credi di essere, Viskovitz?
“Chi sono io?”, mi domandavo. Non trovando risposta chiesi a mio padre.
“Dipende dal contesto», mi spiegò. «Noi camaleonti siamo come la pausa tra due parole.”
“E… la nostra personalità?”
“Che te ne fai di una personalità, figliolo, quando puoi averle tutte? A che ti serve essere te stesso quando puoi sedurre saure fantastiche, ottenere bei voti a scuola e far scappare i tuoi rivali semplicemente dicendo che sei un altro? Prendi esempio da me, che oggi sono il tuo babbo e domani chissà.»
Era sempre la stessa storia. Bastava rimescolare un po’ i colori e gonfiare i diverticoli polmonari per assumere l’aspetto di chi volevi, sicché non potevi fidarti di nessuno, neanche dei parenti. Non a caso in famiglia avevamo tutti un nome che finiva con un punto interrogativo. Io stesso mi chiamavo “Viskovitz?”.
“Non so più in cosa credere, papà, sono confuso…”
“Bravo, figliolo, se sei confuso sei già un camaleonte in gamba. E meglio che il segreto della nostra esistenza non venga svelato, Visko?. Soprattutto a certi serpenti. Adesso sbrigati, è ora di andare a scuola.”
“A scuola? Che accidenti ci vado a fare? Ci danno solo lezioni di lingua.”
“Bene, così imparerai a esprimerti senza appiccicarmela in fronte.”
“Papà, ti assicuro che per la padronanza della lingua fa meglio un bel bacio di tante ore di scuola.”
“Non voglio sentirti parlare di baci, Visko?. Sai che sono pericolosi, che legano. Con le femmine è bene non invischiarsi.”
“Oh, bella, e se sei innamorato?”
“Beh, allora sei nei guai, figliolo. Non c’è sventura peggiore per noi camaleonti.”
“A te è mai capitato?”
Pensoso, alzò un occhio snodabile verso la chioma della terminalia.
“Sì, una volta mi sono innamorato anch’io. Ma ti confesso che non ho mai capito di chi. E poi non riuscivo mai a distinguerla dallo sfondo. E allora diventavo gelosissimo. Se qualcuno sfiorava un ramo pensavo che le carezzasse la coda prensile, se leccava rugiada da una foglia pensavo che le succhiasse un orecchio. Se faceva apprezzamenti sul panorama… Beh, ci vedevo i peggiori sottintesi. Per fortuna l’amore è un fenomeno termico, Visko?, e noi animali a sangue freddo dobbiamo preoccuparcene solo tra le 11 e le 2 del pomeriggio…”
Ne avevo abbastanza del cinismo di quel sauro, e poi chissà se era veramente mio padre. Salutai e mi calai giù da una radice pendula, ma non appena raggiunto lo strato arbustivo, me la squagliai attraverso le selaginelle e le zinziberacee. Prosegui oltre lo stagno delle ninfee, fino all’albero della camaleonte che amavo. Quatto quatto mi arrampicai sul tronco di una cauliflora, curando per bene la mimesi perché non mi scorgesse, e poi mi beai della sua visione. Lei sì che era visibile! Stava specchiandosi nell’acqua raccolta nella foglia cava di un’epifita, e, canticchiando, si spogliava della pelle in un lento strip-tease, mentre il suo corpo anziché mimetizzarsi inventava fantastici colori. Nascosto dietro a un’orchidea saprofita, la centrai con un bacio furtivo. Mi chiesi se fossi il solo che lo stesse facendo. Poi spalmai la lingua su un ramo sperando timidamente che ci si sdraiasse.
“Chi è là?», gridò. Forse avevo fatto rumore.
“Visko?”, ammisi, tralasciando il «vitz». Perché se pronunciavi lettere come «T», «L», «D», «N» о «Z», con la gola secca, c’era sempre il rischio che la lingua vischiosa ti restasse appiccicata al palato superiore.
“E cosa vuoi?”, sibilò. Con un occhio indipendente continuava a specchiarsi, mentre con l’altro mi guardava nell’occhio che la guardava nell’occhio che mi guardava. Le dissi la verità. Le dissi che ero rimasto incantato dai suoi cromatofori cutanei, e mi chiedevo come si facesse a essere così creativi con le squame. Lei mi sorrise.
“Non è difficile”, rispose. “Per essere originali bisogna tornare alle origini, sauro. Il segreto per essere se stessi è saperci rinunciare. Svuotarsi e lasciarsi riempire. Se saprai farlo, voilà, i tuoi colori si metteranno a parlare, e al posto di un punto interrogativo alla fine di quel ridicolo nome, potrai mettercene uno esclamativo. Io sono Ljuba!”. Aveva pronunciato quel difficile nome senza esitazioni, schioccando la lingua come una frusta.
“Vuoi fare un giro?», mi disse improvvisamente. Restai di sasso.
“Un giro?”
“Sì, è la stagione degli amori, e tanto con voi uno vale l’altro… Vieni qua.” Non riuscivo a credere alla mia fortuna. Un moccioso come me con quella fata arboricola! Mi avvicinai e scoprii che i miei colori imitavano i suoi: vermiglioni, turchesi, coquelicots; marezzati, picchiettati, a pois! Caramba, mi dissi, questa dev’essere la felicità. Altro che le mie scialbe compagne di scuola. Per questa avrei scalato le montagne, avrei affrontato vipere e zibetti. E se si fosse confusa con lo sfondo… pazienza, avrei amato ogni foglia, ogni tramonto, ogni fiore, vedendo ovunque le sue squame, e a tutto avrei dato quell’impronunciabile nome: “Llljuba!”
Mi tuffai in quell’arcobaleno. Le carezzai i lobi dermici e mi avvinghiai alla sua cresta, mi lasciai trasportare dalle sue ondulazioni e sprofondai nell’oblio, naufragando nei suoi essudati viscidi, adorando ogni millimetro di quelle squame. Stum. Cascammo giù dal ramo e piombammo sulle spine di una acacia fischiatrice.
Ebbene, l’indomani scoprii che anche la mia sciocca ex fidanzata, Lara, aveva le sue identiche ferite, e così anche la mia spenta e repressa compagna di banco, Jana! Erano la stessa camaleonte!
È stato allora che ho perso le mie ultime certezze.
Ed è lì che finalmente ho trovato me stesso. Ma non l’ho riconosciuto.
Viskovitz, tra sentenze fulminanti e osservazioni demenziali, situazioni assurde e doppi sensi sembra essere nato dalla penna dell’autore solo per divertire: in realtà egli ci racconta, in molteplici vesti e in prima persona, la lotta per la vita, l’amore, la fatica, l’illusione, il fallimento, la gioia… elementi che sono propri non solo del mondo animale ma anche – e soprattutto – della condizione umana. In tutte le pagine del suo romanzo Boffa si diverte ad antropizzare gli animali e, di conseguenza, ad animalizzare gli uomini, per mostrare che, in fin dei conti, non siamo così diversi. Perché è forse arrivato il momento che anche noi, come Viskovitz, dopo esserci posti la fatidica domanda “Siamo animali o bestie?”, impariamo, proprio come lui, che essere animali o uomini vuol dire saper accettare e affrontare ogni esperienza, positiva o negativa, perché tutto ci insegna a vivere una vita che sa essere dura, ma anche molto bella, nonostante le difficoltà, per chi la sa apprezzare…
TITOLO: La donna dei fiori di carta
AUTORE: Carrisi, Donato
EDITORE: Longanesi
GENERE: Noir / romanzo storico / romanzo d’amore
PAGINE: 165
Monte Fumo, Dolomiti, notte tra il 14 e il 15 aprile 1916
Siamo alla vigilia di una battaglia decisiva della prima guerra mondiale. In una caverna buia e umida di quell’immensa cattedrale di ghiaccio che è il monte Fumo due uomini parlano, bevono caffè e fumano sigarette. Uno è un prigioniero italiano che sarà fucilato all’alba, se non rivelerà il suo nome e il suo grado, l’altro, Jacob Roumann, è un medico da campo dell’esercito austriaco che ha solo una notte per convincerlo a parlare, ma che non sa che quello che sta per sentire cambierà per sempre la sua vita, perché quando il destino decide di deviare il corso della nostra esistenza non ci avverte […] Il Fato non fornisce indizi. Non ci sono avvisaglie oppure – per chi ha bisogno di una visione mistica – segni. Accade e basta. E quando succede, si verifica come una cesura. E per il resto della vita sarai costretto a una distinzione. Ciò che c’era prima di quel momento, e il dopo (pag.17).
Il prigioniero promette a Jacob che gli rivelerà la sua identità solo se lui ascolterà la storia che darà risposta a tre domande: chi è Guzman? Chi sono io? E chi era l’uomo che fumava sul Titanic (pag.44)?
E così comincia la sua narrazione, perché per rendere felice un uomo basta offrirgli l’opportunità di raccontare (pag. 99): del resto, come spiega il prigioniero durante il suo racconto, tutti abbiamo bisogno di una passione, o di un’ossessione. Cerca la tua. Desiderala fortemente, e fa’ della tua vita la ragione stessa per cui vivi (pag.40).
La storia narrata dal prigioniero porta Jacob molto lontano: seguire le orme di Guzman vuol dire addentrarsi in luoghi misteriosi (per esempio, tra le montagne che cantano), conoscere personaggi affascinanti (come Madame Li, Dardamel ed Eva Mòlnar), perdersi in vite che si intrecciano vicendevolmente, misurarsi con sentimenti diversi, come l’odio e l’amore…
Già, l’amore.
“Voglio sapere che cos’è l’amore.”
“A che ti serve?”
“Ad avere il cuore di una donna.”
“Tu vuoi possedere il suo cuore?”
“No, me lo ha insegnato mio padre che il possesso è il più grave torto che si possa fare al cuore di una persona amata. Io lo voglio solo in prestito.” (pag. 95)
I fatti che racconta il prigioniero, apparentemente così lontani, pian piano risultano collegati tra loro: nella stessa notte di quattro anni prima il Titanic affondava, un uomo vestito di tutto punto fumava tranquillo un sigaro sul ponte della nave che stava colando a picco e Jacob festeggiava il suo compleanno… Da questo racconto il povero medico condotto prestato a una guerra – un male che forse per carenza di audacia non è in grado di capire, stanco di essere l’ultima speranza di tutti, perché, dopo di lui, rimane solo Dio (pag. 23) – trae la forza necessaria per superare l’orrore di quanto ha dovuto vedere e il dolore lacerante che prova per l’abbandono della moglie, perché ora ha una storia da raccontarle…
Difficile definire il genere di appartenenza di questo libro: il romanzo noir si colloca in un contesto di guerra ricostruito con la precisione che si deve a un romanzo storico, ma le sue pagine sono piene di parole e di immagini che appartengono a un romanzo d’amore, arrivando a sfiorare la poesia, come accade nella struggente lettera che lo chiude… insomma, certamente una sorpresa per chi cerca il Carrisi dei grandi thriller che gli hanno regalato la fama.
La donna dei fiori di carta celebra, insieme all’amore e al vizio del fumo (con buona pace del politicamente corretto, come annota lo stesso autore al termine del romanzo), la capacità di raccontare e di ascoltare. Non è un caso che prima Guzman, poi il prigioniero e infine Jacob si definiscano l’ultimo aedo: il modo in cui le vicende narrate fioriscono l’una sull’altra ricorda davvero l’arte di fare della parola uno strumento di diletto e di fascinazione che fu propria dei cantori dell’antica Grecia, ma che rivive ogni volta che qualcuno, come un moderno Omero […] sa portare agli uomini il conforto dell’immaginazione (pag.61).
TITOLO: Fine pena: ora
AUTORE: Fassone, Elvio
EDITORE: Sellerio editore Palermo
GENERE: Romanzo / Saggio
PAGINE: 210
Torino, 1985
Da oltre due anni è in corso l’istruttoria sulla cosiddetta mafia catanese, che si ingigantisce man mano che si sviluppa. È il troncone principale di un processo curioso, nato a Torino perché a Torino è avvenuto l’arresto in quasi flagranza di uno dei capi, il quale ha deciso di collaborare rivelando molte cose (pag. 14). Tra i 242 imputati del processo c’è anche Salvatore, che si presenta subito come un soggetto particolarmente difficile. Condotto davanti al giudice istruttore per un interrogatorio, Salvatore aveva estratto dalla bocca una lametta che, sfuggita a ogni perquisizione, teneva sotto la lingua, e si era gettato addosso al magistrato. La scorta, che gli era a fianco e non lo perdeva d’occhio un istante, lo aveva bloccato, ma, per quanto tempestiva, non aveva potuto impedire che Salvatore si tagliasse un braccio e spargesse del sangue sulla scrivania e sui fogli, forse anche addosso al giudice […] il messaggio era chiaro: mi batterò fino all’ultimo sangue, del mio non mi importa niente (pag. 26).
Il processo, lungo, difficile, estenuante per i giudici, la giuria e gli imputati, finalmente si conclude. Salvatore, come prevedibile, viene condannato all’ergastolo. Il giorno dopo la sentenza il giudice della Corte d’Assise, Elvio Fassone, narratore e protagonista del romanzo, obbedendo a un inspiegabile impulso, prende carta e penna per scrivere a Salvatore una lettera con cui accompagnare il dono di un libro, Siddhartha, di Herman Hesse. Comincia così un lungo scambio epistolare tra i due. Ci scriviamo da ventisei anni, lui è in carcere da trentuno. È stato condannato per quindici omicidi e altri delitti vari, raggiunto da prove schiaccianti (pag. 10). Realizzo che ventisei anni sono un tempo enorme. Nemmeno tra due amanti è pensabile uno scambio di lettere così lungo. Per la prima volta mi volto indietro e considero questa montagna di tempo, la cui scalata abbiamo pagato entrambi invecchiando. Per la prima volta mi trovo di fronte all’idea che questa corrispondenza poteva e può finire. A dire il vero, mi ero già prospettato questa evenienza, ma pensavo che il carteggio sarebbe cessato per causa mia, non sua. (pag.12) Nella scheda personale di Salvatore, in bella evidenza, c’è scritto “fine pena: mai”. La tecnologia ha sostituito le cifre a queste tre lettere pesanti come un macigno, e nella scheda che pretende un numero è scritto sarcasticamente l’anno “9999”. Ma il senso dell’eternità senza sbocco rimane intatto. Ebbene, Salvatore ha voluto sostituire la parola “mai” con la parola “adesso”. La pena è finita, la recita terminata, la giovinezza non è mai sbocciata. Tolgo il disturbo, me ne vado. Fine pena: ora. (pag. 13).
La vicenda di Salvatore – una storia vera – viene ricostruita in un romanzo che ha il chiaro intento, come scrive l’autore, di innescare un dibattito sull’ergastolo (ostativo e ordinario) e sul fatto che una persona non è mai tutta nel gesto che compie. Una delle pagine più emotivamente coinvolgenti del libro riferisce un breve dialogo tra Salvatore e il giudice a proposito di una sorta di predestinazione al male che il giovane avverte dentro di sé e che attribuisce al luogo in cui è nato.
“Presidente, lei ce l’ha un figlio?”.
Ne ho tre, e il maggiore ha solo qualche anno in meno di Salvatore.
“Lo so”.
Ci risiamo. E allora perché me lo chiede?
“Glielo chiedo – ha intuito la domanda – perché le volevo dire che se suo figlio nasceva dove sono nato io, adesso era lui nella gabbia; e se io nascevo dove è nato suo figlio, magari ora facevo l’avvocato, ed ero pure bravo”.
“Lo penso anch’io che se lei faceva l’avvocato era molto bravo” dico, e balbetto qualche cosa di saggio, del genere non tutti quelli che nascono a Catania, fosse pure nel suo Bronx, finiscono in prigione (pag. 42).
Fassone fa emergere, in queste pagine, la voglia di riscatto di Salvatore, che il detenuto affida alle lettere che scrive proprio a colui che lo ha condannato: passando attraverso la rabbia, la ribellione, lo sconforto, la fiducia, la positività, l’orgoglio… Salvatore coltiva la speranza di uscire dal carcere, prima con dei brevi permessi e poi in modo definitivo. Questa speranza diventa per il giudice l’occasione per riflettere sul concetto di permesso, di cui egli riporta due diverse letture. Il permesso ha un suo profilo individuale e “pulito”, che discende dalle logiche del trattamento: è un premio per il detenuto che ha mostrato di accogliere e praticare i valori diversi che dovranno allontanarlo dal reato; è un mezzo per riagganciare qualche rapporto con il mondo nel quale dovrà tornare; è un traguardo che illumina i giorni piatti del detenuto e lo rende più operoso e disponibile; è uno stimolo a collaborare con l’istituzione anziché porsi in posizione conflittuale con essa. Intorno a questo aspetto fiorisce la piccola letteratura emozionale dello spaesamento, della disabitudine a tutto, del mondo sconosciuto e aggressivo.
Ma, secondo altri punti di vista, il permesso presenta aspetti assai meno idilliaci. Per chi vive la reclusione in modo recisamente antagonista, esso è uno strumento di addomesticamento a buon mercato, una lusinga e una costante minaccia di perdita del beneficio, che anestetizza qualsiasi lettura “politica” della detenzione e ne garantisce la funzione oppressiva e totalizzante (pag. 145).
La riflessione si allarga, in un’altra pagina, alla definizione del concetto di certezza della pena: l’espressione è venuta a tradurre l’insofferenza verso un preteso lassismo che non ci tutela più contro i malandrini, i quali, a detta della vox populi, quando delinquono non sono più perseguiti, e, quando a fatica lo sono, sgusciano tra le maglie di una giustizia imbelle. La certezza della pena, insomma, significa che quell’altro cittadino, quello che non delinque e che deplora, deve essere certo che la pena sarà irrogata in tutto il suo rigore, ed espiata in tutta la sua intransigenza (pag. 155).
Per aiutare a riflettere sulla vicenda di Salvatore e sulle domande che essa porta inevitabilmente con sé, il giudice, smessi i panni del narratore, propone, al termine del romanzo, una breve appendice, un piccolo saggio in cui spiega e motiva, con la competenza di chi è del mestiere, la sua posizione in proposito.
Comunque la si possa pensare – e in ogni caso è sempre un bene confrontarsi e ascoltare le ragioni anche e soprattutto di chi non la pensa come noi – la lettura di questo testo introduce il lettore nel mondo di Caino e di Abele, lo mette di fronte alla certezza del peccato e alla possibilità della redenzione, lo immerge nell’eterno conflitto tra Bene e Male, gli fa valutare l’importanza della cultura e della scuola nella formazione di un individuo (Salvatore teme che i figli della sorella, che hanno il padre in carcere, una volta abbandonati a se stessi facciano inevitabilmente la sua fine e prova a riscattarsi proprio con lo studio, lui che è stato cacciato da ogni scuola!), gli permette di conoscere i travagli di due persone di fronte a una pena che spesso risarcisce una vita cambiandone un’altra in modo definitivo… Tutto questo forse – ma è un parere del tutto personale – perdendo un po’ troppo di vista le vittime, a cui è riservato solo un fugace accenno (pag. 141).
Non è certo facile trovare il modo in cui conciliare il valore riabilitativo della pena – previsto dalla Costituzione – e il giusto risarcimento della vittima, la possibilità di dare un nuovo senso alla vita di un condannato e la legittima domanda di sicurezza della collettività, ma un punto di incontro si trova sempre, se lo si desidera: basterebbe forse interrogarsi e confrontarsi in proposito serenamente, senza ideologie e preconcetti…
TITOLO: Il latino lingua immortale
AUTORE: Feltri, Vittorio
EDITORE: Mondadori
GENERE: Saggio
PAGINE: 151
Da Roma… ai giorni nostri
Vittorio Feltri in questo saggio si propone di far capire al lettore non solo la bellezza della lingua latina, ma anche quanto essa possa costituire ancora oggi una grande risorsa per tutti noi. Scrive nella Prefazione Giulio Dellavite: Un plus! E lo pronuncio con la “u” bella piena latina e non con una “a” biascicata anglofona. Il latino è un plus: per qualcuno è un di più, ma per qualcun altro è un valore aggiunto. Il direttore Feltri, con la sua penna egregia – dal latino ex grege, fuori dal gregge -, offrendo pagine dense di storia e di storie sue mostra come il latino non sia una lingua morta, ma un lievito madre. (pag. VII).
Un lievito, il latino, che è ancora ben vivo e attivo. Da qualche parte c’è un errore in agguato: credere che il latino sia comunque un’entità circoscritta nel passato, che sia solo testimonianza di un mondo ormai sparito, dissolto per sempre: nulla di più sbagliato, perché il latino è vivissimo, è tra noi, e si è insinuato nel nostro tempo non solo conservandosi ovviamente nell’italiano che tutti utilizziamo, ma anche strutturando il lessico della scienza, della medicina e della farmacologia, della tecnologia e dell’informatica, del marketing e della pubblicità (pag.7).
Il fatto è che spesso non ci accorgiamo di quanto questa lingua sia ancora presente in mezzo a noi. Davvero possiamo divertirci con una lunga lista di parole che usiamo di continuo e della cui provenienza latina abbiamo ormai smesso di renderci conto. Il motivo è che non ne conosciamo l’atto di nascita, oppure, più semplicemente, che sono diventate routine e dunque nemmeno quel suono vagamente latineggiante ci riporta al mondo di Cicerone (pag.12).
È il caso, per esempio, della parola monitor. Proprio nel monitor, spiega infatti Feltri, c’è ancora latino, latino camuffato. È un elemento del computer, e capisco che abbia perciò un’aria così inglese, invece garantisco che è ancora latino, quello vero. Intendiamoci, la parola rimbalza di nuovo nella nostra lingua grazie all’inglese, che l’ha ripescata dal passato e le ha ridato una nuova vita. Ma la parola viene da monere, che significa “ammonire”, quindi siamo autorizzati a tradurre monitor con “ammonitore”, cioè lo strumento che ci avverte di quel che sta avvenendo (pag. 19). Ma è anche il caso di parole insospettabili: non direste mai che il mica che inseriamo così spesso nei nostri discorsi venga addirittura da Petronio, l’autore del Satyricon. Ciò che per noi è diventato un avverbio, che più o meno significa “affatto”, per i latini era invece un sostantivo che indicava la briciola di pane, dunque era qualcosa di insignificante e con i secoli si è trasformato in una negazione (pag. 22).
Ma non è certo per conoscere l’etimologia di molte parole che appartengono al nostro vocabolario che è bene apprendere il latino. Ho letto recentemente – scrive Feltri – che, mentre noi siamo fermi a “latino nelle scuole sì” e “latino nelle scuole no”, ci sono paesi all’estero in cui molte aziende apprezzano che nel curriculum di chi cerca lavoro ci sia la conoscenza del latino, e questo ha moltiplicato il successo di corsi e docenti che lo insegnano. Il motivo è che un buon traduttore di testi è solitamente un eccellente risolutore di problemi in tempi rapidi, che ha acquisito la capacità di tenere sotto controllo informazioni complesse. Pensate a cosa possa cercare un’azienda oggi e ditemi se non sono le caratteristiche di cui i selezionatori vanno più ossessivamente a caccia (pag. 31).
Per non parlare, poi, di un’altra delle prerogative di questa lingua… Devo il mio sconfinato amore per il latino alla caratteristica che a mio avviso merita più di tutte la nostra ammirazione, ossia la sua capacità di racchiudere in un numero ridottissimo di parole anche concetti intensi, profondi e complessi. Esprimere in italiano la stessa idea, e il principio è valido per molte altre lingue, richiederebbe invece lunghe perifrasi, e dunque un numero di parole molto più alto e quasi certamente più noioso (pag. 35).
E poi ci sono le citazioni… parole magiche che evitano tutti i fronzoli e che sigillano il concetto, fin quasi a farlo sembrar immortale, come se una frase sola avesse il potere di farti viaggiare, di trasportarti prima nell’antichità dei gloriosi antenati e poi di nuovo ai tempi nostri. Non hai pronunciato che una frase, e sembra che sia tuo il merito di aver detto qualcosa che riesce a vivere e a dispensar saggezza da duemila anni (pag. 40).
Una lingua, dunque, il latino, caratterizzata da due fondamentali prerogative: articolate strutture sintattiche, che insegnano a razionalizzare, a risolvere informazioni complesse e a decodificare un messaggio mettendo in campo rigorosi processi di analisi (e qualche buona intuizione); un lessico vario, denso di significato e con una capacità di sintesi che punta dritto al cuore di ciò che si dice: tutto ciò fa sì che il latino si stagli come un gigante nell’epoca del politicamente corretto, che banalizza e impoverisce la lingua eliminando parole che improvvisamente non possiamo più pronunciare, poiché dobbiamo imparare a considerarle scorrette, termini che potrebbero offendere chi se ne sente colpito […]. Se io volessi tener conto, ogni volta che mi esprimo, della sensibilità di ciascuno degli abitanti di questo pianeta, chiosa Feltri, avrei di fronte a me una sola soluzione possibile: tacere, e dovrei farlo per sempre, perché a causa di qualunque parola, di qualunque mia frase apparentemente innocente, potrei trovare qualcuno che mi impone di non usarla, qualcuno che proverà a vietarmela in nome del principio indiscutibile che se ne sente turbato. Proprio non riusciamo a convivere tra di noi con l’idea di lasciarci in pace, abbiamo bisogno di sindacare, di indignarci, di contestare, e se possibile di proibire. Se tu parli in un modo che a me non piace, vuol dire che parli male e che sarai costretto a eliminare frasi dal tuo universo espressivo, oppure a modificarle come io ti ordinerò di fare, sulla base della mia morale (pag. 127). Un atteggiamento che è lontanissimo dalla libertà e dalla concretezza espressiva di questa lingua, nata da agricoltori e quindi diretta, incisiva, in grado di esprimere idee, concetti e valori senza avere il timore delle parole, che sono semplicemente il rivestimento del pensiero… una lingua, insomma, come ebbe modo di scrivere un grande autore della nostra letteratura, Giovannino Guareschi, precisa, essenziale. Verrà abbandonata non perché inadeguata alle nuove esigenze del progresso, ma perché gli uomini nuovi non saranno più adeguati ad essa. Quando inizierà l’era dei demagoghi, dei ciarlatani, una lingua come quella latina non potrà più servire e qualsiasi cafone potrà impunemente tenere un discorso pubblico e parlare in modo da non essere cacciato a calci giù dalla tribuna. E il segreto consisterà nel fatto che egli, sfruttando un frasario approssimativo, elusivo e di gradevole effetto sonoro potrà parlare per un’ora senza dire niente. Cosa impossibile con il latino.
Gli aneddoti, le considerazioni, le riflessioni, i ricordi personali e della memoria collettiva che illustrano alcuni dei più importanti e celebri detti latini citati nel testo – dal do ut des al per aspera ad astra, dal carpe diem all’homo homini lupus – rendono davvero piacevole la lettura di questo saggio. Innamoratevi dunque, come Feltri, di questa lingua e della libertà di pensiero che essa dona. Perché amare e far amare il latino è uno dei regali più belli che si possono fare a sé stessi e agli altri…
TITOLO: La favola di Natale
AUTORE: Guareschi, Giovannino
EDITORE: Bur
GENERE: Racconto (favola)
PAGINE: 72
Un campo di concentramento tedesco, dicembre 1944
Questa favola è nata in un campo di concentramento del Nordovest germanico, nel dicembre del 1944, e le muse che l’ispirarono si chiamavano Freddo, Fame e Nostalgia (pag. 5). Così Giovannino Guareschi nella Premessa a questo intenso racconto che egli ha composto, trascrivendolo su gualciti e bisunti pezzetti di carta, in un campo di concentramento tedesco e che fu letto per la prima volta la sera della vigilia di Natale nella baracca in cui egli era il prigioniero 6865…
Ci sono esperienze – la malattia, la morte di una persona cara, la povertà… – che danno alla vita un sapore diverso. Tra di loro c’è sicuramente anche quella della prigionia. In prigionia – scrive infatti Guareschi sempre nella Premessa – anche i colori sono una favola, perché nel lager tutto è bigio, e il cielo, se una volta è azzurro, o se un rametto si copre di verde, sono cose di un altro mondo. Anche la realtà presente diventa nostalgia. Noi pensavamo allora alle cose più umili della vita consueta come meravigliosi beni perduti, e rimpiangevamo il sole, l’acqua, i fiori come se ormai non esistessero più (pag. 6). Guareschi è consapevole del fatto che spiegare cosa sia la prigionia è perfettamente inutile. Chi l’ha fatta lo sa, chi non l’ha fatta non lo può capire. Ma il valore della testimonianza è comunque fondamentale, perché è utile ricordare il male trascorso: ciò aiuta molto a sopportare i mali del presente e permette di ritrovare, tra le sofferenze trascorse, quei pensieri onesti e puliti che solo nella sofferenza possono vivere (pag. 73).
Un bambino, Albertino, la nonna, il cane Flik e una piccola Lucciola, la notte di Natale attraversano un bosco per andare dal babbo, prigioniero in un paese lontano. Cammina cammina (perché questa è proprio una favola!) i protagonisti vivono molte avventure e incontrano numerosi personaggi: una locomotiva, che li trasporta per un tratto, una gallina padovana residente all’estero, i Funghi Buoni e i Funghi Velenosi, la Formica, le Cornacchie, i guardiani del bosco, le Api e i Passerotti, Babbo Natale e la Befana, i re Magi e i Nanetti…
In questa atmosfera da favola la penna di Guareschi – a dispetto delle circostanze della composizione del racconto – fatica a trattenere la battuta di spirito e la comicità che la caratterizzano. Ne è un piccolo capolavoro la pagina in cui la poesia di Natale subisce l’opera della censura (che ricorda, ahinoi, le moderne cancellazioni!):
Cominciò a leggere i versi scritti sulle ali.
Din – don – dan: la campanella
questa notte suonerà…
“No!” disse. “Proibito fare segnalazioni acustiche notturne in tempo di guerra!”
E, con un pennellino intinto nell’inchiostro di Cina, cancellò molte parole. Poi, di lì a poco, scosse ancora il capo.
Una grande, argentea stella
su nel ciel s’accenderà…
“Niente! Contravvenzione all’oscuramento!” disse. E giù pennellate nere.
Latte e miele i pastorelli
al Bambino porteranno…
“Niente! Contravvenzione al razionamento!” borbottò. E giù ancora con il pennello.
I Re Magi immantinente
sul cammello saliranno…
“Niente!” urlò furibondo. “Basta coi re! Guai a chi parla ancora di re! “E giù pennellate grosse così. (pag.13)
La povera poesia riprende il suo cammino, ma ormai, così conciata, chiosa Guareschi, sembra una poesia ermetica!
Già, perché ora è il momento di nuove poesie, che descrivono impietosamente la guerra e il male che essa porta con sé:
Chi più pensa ai giocattoli
in questa triste Terra?
Tutti adesso lavorano
soltanto per la guerra!
Non più trenini elettrici
per i bambini buoni:
il ferro, ora, si adopera
solo per far cannoni!
Cercar cavalli a dondolo?
Sono pretese strane:
adesso, il legno, l’usano
per fabbricare il pane!
(pag. 18)
E così, in questa notte santa, nascono contemporaneamente il Dio della Pace e il Dio della Guerra, ognuno pronto a regnare nel suo paese. Il Paese della Guerra è tutto il contrario di quello della Pace: perché non c’è mai il sole e il cielo è color del catrame, e nei campi non fiori o messi spuntano, ma baionette; e sugli alberi maturano bombe. E gli uomini si vestono di ferro e i bambini non nascono sotto i cavoli, ma li fabbricano a macchina e perciò hanno tutti il cuore di ferro e la testa di ghisa (pagg. 37 – 38), in tutto simili al loro re, che, appena nato, è scaldato, nella sua culla corazzata, dal fiato micidiale di un lanciafiamme e dallo scappamento del carro armato… (pag.69); il suo corteggio è accompagnato da due feroci aquile che reggono fra gli artigli un drappo nero con una scritta a caratteri di sangue: “Guerra agli uomini di buona volontà” (pag.65).
C’è modo di vincere la guerra e il male? Sì. Ed è la speranza, quella che Guareschi volle tenere viva in quella drammatica vigilia di Natale recitando questa favola – accompagnata dalle musiche scritte da un suo compagno di prigionia, Coppola – a tutti coloro con cui condivideva questa terribile esperienza. Ci sono gli angeli, a proteggerli. Gran lavoro, durante la guerra, per l’aviazione del buon Dio. Angeli da ricognizione incrociano sui luoghi delle battaglie e segnalano eventuali concentramenti d’anime. Angeli da trasporto accorrono e caricano le anime e le portano in cielo. Angeli da caccia difendono le formazioni dagli attacchi di neri diavoli alati. Mentre gli Angeli bombardieri rovesciano sulle case, sopra gli ospedali, sopra i campi di prigionia grossi carichi di sogni, distruggendo così le opere nefaste della disperazione (pag. 33).
I sogni e la speranza vinceranno dunque il male? Nessuno ne è certo, ma tutti ce lo auguriamo. E anche Guareschi, che chiude la sua favola nel modo più tradizionale possibile, con una filastrocca che si fa portavoce di questo augurio:
Stretta la foglia – larga la via
dite la vostra – che ho detto la mia.
E se non v’è piaciuta – non vogliatemi male,
ve ne dirò una meglio – il prossimo Natale,
e che sarà una favola – senza malinconia:
“C’era una volta – la prigionia…” (pag. 72)
Una lettura semplice questa favola, ma densa di significato e capace di scaldare il cuore in questi giorni di festa in cui non tacciono le armi e i loro echi. Procuratevi questa edizione, illustrata con i disegni che ha fatto lo stesso Guareschi, che la impreziosiscono e che rendono questo racconto davvero speciale per grandi e piccoli…
TITOLO: La Dama e il Moro
AUTORE: Lomartire, Carlo Maria
EDITORE: Mondadori
GENERE: Romanzo storico / biografia romanzata / romanzo d’amore
PAGINE: 224
Milano, 1489
Leonardo dipinse La Dama con l’ermellino tra il 1488 e il 1490. Su questo gli storici dell’arte e gli studiosi del genio vinciano sono unanimi, così come concordano nel considerare Cecilia Gallerani, la giovanissima amante di Ludovico il Moro, la giovane che vi è ritratta. L’opera, olio su tavola, è considerata una delle più belle di Leonardo […]; ebbe subito un grande successo presso le corti italiane ed europee, tanto che molte aristocratiche, come Isabella d’Este, marchesa di Mantova, a cui Cecilia l’aveva mostrata, cercarono, inutilmente, di farsi ritrarre a loro volta da Leonardo. Per secoli il quadro ebbe una storia confusa, tanto che l’attribuzione a Leonardo venne dimenticata, finché venne definitivamente riconosciuta verso la fine del XVIII secolo. Durante la Seconda guerra mondiale, i proprietari di allora, per metterlo al riparo, lo nascosero nel castello di Wawel, a Cracovia, dove fu trovato dalle truppe tedesche e leggermente danneggiato, danno a cui poi si rimediò con un sapiente restauro. Passando quindi di mano in mano rimase in possesso di ricchi collezionisti polacchi finché nel 2016 fu ceduto al governo di Varsavia […]. Per molti La dama con l’ermellino è il ritratto più bello dipinto da Leonardo, più della Gioconda, che probabilmente deve il suo primato in termini di prestigio e la sua fama anche al fatto di trovarsi nel museo più famoso al mondo (pagg. 223 – 224).
La giovane Cecilia Gallerani (1473 – 1536) divenne l’amante di Ludovico il Moro (1452 – 1508) quando aveva solo sedici anni. Era di una bellezza molto particolare, conturbante, quasi inquietante […] il viso dall’ovale perfetto con gli zigomi alti e il mento affilato, la bocca ben disegnata con il labbro inferiore carnoso e naturalmente atteggiata a un sorriso lieve, quasi trattenuto. E poi lo sguardo, lo sguardo molto particolare e indecifrabile di quella giovanissima donna che tuttavia appariva già matura: uno sguardo che riusciva a combinare inspiegabilmente attenzione, intelligenza, arguzia, ironia e soprattutto una misteriosa ma intensa carica di sensualità, una promessa di erotismo velata da un sorriso appena accennato (pag.6). Insomma: bellissima, intelligente, attenta, curiosa, amante della poesia e del latino (in una città in cui per le donne era considerato più che sufficiente saper leggere, scrivere e fare di conto), Cecilia riesce ben presto a conquistare il cuore del reggente di Milano, già impegnato a contrarre un matrimonio politico con la giovane Beatrice d’Este, figlia di Ercole I, duca di Ferrara.
È proprio la consapevolezza dell’inevitabile fine che sarà costretto a imporre a questo sentimento così forte il motivo per cui Ludovico chiede a Leonardo da Vinci di ritrarre Cecilia: il vivo desiderio di serbarne il ricordo lo spinge ad affidare a Leonardo il compito di renderla sempre presente ai suoi occhi, oltre che al suo cuore. Cecilia comincia così a recarsi nello studio di Leonardo, che si trova di fianco al Duomo di Milano, per posare per lui. Questi incontri si trasformano ben presto in piacevoli momenti di confronto: Leonardo spiega a Cecilia che non intende realizzare un semplice ritratto del suo viso, ma un’opera in cui si rifletta l’intera sua persona, fatta di sentimenti, emozioni, aspirazioni…
Ed è questo che Ludovico vede quando può ammirare per la prima volta il ritratto della sua amata. Era lei, era Cecilia, che, col capo appena girato a sinistra, guardava verso di lui, vestita di un bell’abito di velluto azzurro dalle larghe maniche con grandi intarsi color cremisi. Al collo aveva una lunga collana di granati neri che egli riconobbe perché era uno dei suoi regali da lei più amato in quanto quelle pietre erano simbolo di fedeltà. Sul capo, come una cuffia, un sottilissimo velo del colore dei lunghi capelli castani stretto a chiuderle un’acconciatura a coazzone, cioè raccolti in treccia dietro la nuca, secondo la moda. Un sottile laccio nero sulla fronte tiene fermo il velo (pag. 76).
Ma l’elemento più intrigante del ritratto è sicuramente l’ermellino che Cecilia tiene in braccio. Leonardo scelse questo animale per diversi motivi. I bestiari medioevali lo consideravano un simbolo di purezza e di incorruttibilità, poiché esso fa di tutto per mantenere immacolato il suo mantello bianco: inseguito dal cacciatore preferisce farsi catturare piuttosto che sporcarsi fuggendo sotto terra. Dunque il candore dell’ermellino acquisisce, per Leonardo, un valore simbolico, poiché rimanda alla purezza e all’onestà dei sentimenti di Cecilia per il Moro. Inoltre il nome greco dell’ermellino è γαλῆ (galé), circostanza che creava un’evidente allusione al cognome di Cecilia. Va infine ricordato che Ludovico era stato insignito dal re di Napoli, Ferdinando I di Aragona, del titolo di cavaliere dell’Ordine dell’Ermellino: non a caso il piccolo ermellino è rappresentato con una zampetta anteriore sollevata, con la tipica posa con cui si ritraggono gli animali negli stemmi araldici. È dunque proprio il Moro colui che è mollemente adagiato tra le braccia di Cecilia, come Ludovico comprende non appena scorge il ritratto: Certo, sono io quell’ermellino, lo capisco anche dal modo in cui lei carpisce l’animale, quasi lo concupisce, mi trattiene con quella splendida mano. Proprio la mano destra, infatti, bianchissima e affusolata, era al centro del quadro, il punto più illuminato dal fascio di luce che entrava dalla finestra […]. Cosicché, appena Ludovico domanda: “Perché guarda verso sinistra? Che strana posizione, inconsueta: è come se aspettasse qualcuno che sta arrivando”, Leonardo risponde: “Aspetta voi, signore”. (pag. 77).
Il resto della ricostruzione storica del romanzo si sofferma sulla vita, sulla cultura e sulle guerre della Milano sforzesca, in cui Cecilia gioca un ruolo di primo piano fino alla sua morte (avvenuta a sessantrè anni, a Cremona) e in cui c’è spazio per riflessioni storiche di – purtroppo – sempiterna attualità (è costume tipicamente italiano dividersi di fronte al nemico per correre poi sul carro del vincitore, pag. 185). Ma sono certamente le pagine che raccontano l’amore tra la Dama e il Moro e la realizzazione dello splendido ritratto quelle che si imprimono maggiormente nella mente del lettore, rendendo ancora più grande l’ammirazione per questo meraviglioso capolavoro di Leonardo…
TITOLO: Racconto di un naufrago
AUTORE: Márquez, Gabriel García
EDITORE: Mondadori
GENERE: Reportage / romanzo d’avventura
PAGINE: 116
Colombia, febbraio 1955
La storia narrata in questo libro è vera: essa è la trascrizione del racconto che un allora giovane giornalista, Gabriel García Márquez, ascolta da Luis Alejandro Velasco, marinaio della marina militare colombiana, imbarcato su un cacciatorpediniere e sbalzato in mare da un’onda anomala con altri sette compagni. Il racconto, pubblicato in quattordici puntate su un quotidiano di Bogotá, riscuote subito un incredibile successo, perché porta alla luce una pericolosa verità: la nave non è stata in grado di tenere il mare non per una violenta tempesta, come riferito dagli organi di informazione, ma perché l’ha fatta sbandare un carico mal assicurato di radio, televisori, lavatrici e frigoriferi, provenienti dagli Stati Uniti e destinati a entrare nel Paese di contrabbando. Le rivelazioni del naufrago provocano la forte reazione del governo colombiano, che è in mano a un dittatore: il giornale per cui scrive Márquez viene chiuso e il naufrago, prima osannato e cercato da tutti, va incontro a un destino di oblio…
Come spesso succede nei testi di Márquez, lo sviluppo della narrazione viene anticipato fin dal titolo: il romanzo, infatti, ha come titolo completo Racconto di un naufrago che andò per dieci giorni alla deriva in una zattera senza mangiare né bere, che fu proclamato eroe della patria, baciato dalle reginette di bellezza e reso ricco dalla pubblicità, e poi aborrito dal governo e dimentico per sempre.
Non è dunque l’attesa di conoscere l’esito del naufragio, ma il racconto stesso del naufragio e delle sue conseguenze ad appassionare chi si avventura nella lettura di questa storia. Una storia che il giornalista affida ben presto, dopo una breve introduzione, alle parole del protagonista, un ragazzo di vent’anni, tarchiato, con una faccia più da trombettiere che da eroe della patria, che Márquez lascia parlare in prima persona perché ha un istinto eccezionale nell’arte di raccontare, una capacità di sintesi e una memoria stupefacenti, e abbastanza dignità selvatica da saper sorridere del proprio eroismo (pag. 5).
E così il naufrago rivive il terribile momento del naufragio, preceduto da giorni di inquieti e strani presentimenti… Tirai fuori la mano per guardare l’ora, ma in quell’istante non vidi né il braccio, né la mano, né l’orologio. Non vidi l’onda. Sentii che la nave si rovesciava del tutto e che il carico al quale mi appoggiavo stava rotolando via. Mi drizzai in piedi, in una frazione di secondo, e l’acqua mi arrivava fino al collo […] Cercando di venire a galla, nuotai una cosa come uno, due, tre secondi. Continuai a nuotare verso l’alto. Mi mancava il respiro. Affogavo. Cercai di aggrapparmi al carico, ma il carico non era più lì. Non c’era più niente. Quando riuscii a venire a galla non mi vidi intorno altro che mare. Dopo un secondo, a un cento metri di distanza, la nave venne fuori dalle onde, grondando acqua da tutte le parti, come un sottomarino. Solo allora mi resi conto che ero caduto in mare (pagg. 23 – 24).
L’odissea del giovane marinaio dura dieci interminabili giorni, in cui egli è costretto ad affrontare – in totale solitudine, sdraiato in una zattera bianca – il mare, la fame, la sete, gli squali, le notti, il buio, il calore del sole… Con sé ha soltanto un orologio, una chiave, una catenina e alcune cartoline. Appena caduto in acqua è convinto che i soccorsi arriveranno a breve. I minuti erano lunghi e intensi. Il sole mi bruciava la faccia e le spalle e le labbra mi ardevano, spaccate dal sale. Ma in quel momento non avevo né fame né sete. L’unico bisogno che avevo era che comparissero gli aerei (pag. 34), poi si rassegna a trascorrere la notte in mare… La notte del 28 febbraio – che fu la mia prima notte in mare – guardavo l’orologio a ogni istante. Era una tortura. Disperato decisi di togliermelo, di mettermelo in tasca per non essere dipendente in quella maniera dall’ora. Quando mi sembrò di non farcela più a resistere, erano le nove meno venti. Non avevo ancora né fame né sete ed ero sicuro che avrei potuto resistere fino al giorno dopo, quando sarebbero arrivati gli aerei (pag. 37).
Ma gli aerei non arrivano, né il giorno dopo né in quelli successivi. In compenso arrivano la sete, la calura del sole, il freddo della notte e puntuali, tutti i pomeriggi, alle cinque, gli squali. Il racconto del naufrago è fatto di stati d’animo e di sensazioni, di un senso di straniamento, di allucinazioni e di paure immotivate, come quella che lo assale al quinto giorno di deriva, il ricordo della storia di un marinaio che durante la guerra, dopo che la sua nave era stata distrutta da una mina, era riuscito a raggiungere a nuoto un’isola vicina. Se ne sta lì ventiquattro ore, nutrendosi di frutta selvatica, finché non lo scoprono i cannibali, lo tuffano in un pentolone di acqua bollente e lo cuociono vivo. Cominciai subito a pensare a quell’isola. Ormai riuscivo a immaginarmi la costa soltanto come un territorio popolato di cannibali. Per la prima volta nel corso dei miei cinque giorni di solitudine in mare, il mio terrore cambiò direzione: ora avevo meno paura del mare che della terra (pag. 53).
Ma la terra alla fine compare… Vedevo perfettamente la folta vegetazione illuminata dal tiepido sole della mattina, quando cercai con il piede per la seconda volta il fondo. E finalmente la terra era lì, sotto le mie scarpe. Dà una sensazione strana mettere un piede sulla terra dopo dieci giorni alla deriva per il mare (pag. 98).
Con la salvezza arrivano la fama, gli onori, le interviste e i soldi per la pubblicità (un orologio che resiste a un naufragio deve essere adeguatamente sponsorizzato!), ma tutto questo, per il naufrago, non ha alcun senso… non ho fatto nessuno sforzo per essere un eroe. Tutti gli sforzi che ho fatto sono stati per salvarmi. Ma siccome la salvezza è venuta circondata da un’aureola, siccome è stata premiata con il titolo di eroe come un uovo di pasqua con dentro la sorpresa, non mi resta altro da fare che sopportare la salvezza, così come è venuta, con l’eroismo e tutto il resto (pag. 111).
Márquez non ha mai apprezzato questo romanzo. Nell’introduzione dice di averne consentito la pubblicazione con leggerezza e di non essersi poi opposto, perché non ci si rimangia la parola data. Eppure chi, come me, ama la sua scrittura, non può che giudicare positivamente anche il resoconto di questa terribile esperienza, in cui si intrecciano le pennellate che ritraggono il mare e i suoi abitanti, la minuziosa descrizione degli stati d’animo del naufrago, il conteggio dei giorni che si fanno speranza e delle notti che portano paure, la rappresentazione delle fantasie e dello smarrimento di una mente sempre più annebbiata, senza dimenticare la denuncia delle responsabilità del governo colombiano, perché la penna di Márquez sa sempre trasformare la storia in Storia…
TITOLO: Quattro anni in Siberia
AUTORE: Micheloni, Firmino
EDITORE: Grafiche Manzanesi
GENERE: Romanzo autobiografico
PAGINE: 35
Da Udine alla Siberia, agosto 1942 – marzo 1946
Ogni vita umana, in quanto unica e irripetibile, meriterebbe un libro. Alcune persone decidono di raccontare il proprio vissuto, ed è così che nascono i romanzi autobiografici, che narrano, in prima persona, delle vicende o l’intera vita del protagonista.
Quattro anni in Siberia racconta uno squarcio di vita di un giovane alpino, poco più che ventenne, che l’8 agosto 1942 parte per il fronte russo e rientra in Italia, dopo anni terribili trascorsi in Siberia, il 28 marzo 1946.
Il 15 dicembre 1942 la divisione di alpini di cui fa parte, la Julia, viene inviata a sostenere la prima vera battaglia al fronte. È una cosa che spacca il cuore lasciare baracche e alloggiamenti nel gelo implacabile dell’inverno russo e buttarsi in una disperata avventura nel mare di ghiaccio, dove sono in agguato la morte e il mistero (pag.2). La battaglia scoppia, furiosa. In breve c’è una lugubre distesa di morti sulle quote contese: carname glorioso, su cui non scenderà mai una lacrima d’amore e di pietà. Non c’è tempo per riprendersi, non c’è modo di riposare: nei momenti di sosta, se non hai le mani paralizzate dal gelo, ti scavi nel ghiaccio una buca e lì ti accucci al riparo dal vento che rade la steppa fischiando (pag.4).
La battaglia è persa. Arriva, dopo diciassette giorni di martirio, l’ordine di ritirata. La colonna si mette in marcia. Bisogna camminare, anche quando senti le gambe incapaci di rispondere agli stimoli della volontà, anche quando ti senti morire di fame e di disperazione, anche quando ti accorgi di essere sull’orlo della pazzia. E cammini ancora, stringendo i denti, mordendoti a sangue le labbra per resistere al fascino della neve che, morbida e bianca, ti attira a sé irresistibilmente, ti invita maliziosa ad abbandonarti su di lei a dormire… finalmente, e a morire. Cammini ancora perché, quando stai per affondare nella voragine dello sconforto, ti esplode nella mente, a darti una scossa violenta, l’immagine della tua mamma che aspetta, alla quale devi portare il meraviglioso dono di tornare vivo tra le sue braccia: e rivedi la tua casa inondata di sole: devi arrivarci (pag.6).
Sono le 8 del mattino del 21 gennaio quando, all’orizzonte, il drappello di alpini in marcia vede concretizzarsi la sua più grande paura: una colonna di carri armati russi. Dopo aver informato il comandante, il giovane alpino appende uno straccio bianco alla canna del suo 91 e muove incontro al nemico. Gli alpini si arrendono. La Julia invitta ha cessato di esistere.
Cominciano così i lunghi mesi di prigionia, quando trovare delle patate gelate dure come sassi significa accingersi a mangiare un piatto prelibato e poter guidare un camion (sotto la minaccia di una pistola) per recuperare dai villaggi il materiale bellico abbandonato diventa un’occupazione invidiabile, perché permette di non pensare a ciò che ti circonda e di ricevere una razione quotidiana di pane nero e pesce salato…
Il giovane alpino non viene meno, in questo triste scenario, ai valori che la sua famiglia gli ha insegnato. Un giorno vede, accucciato sulla soglia di un’isba, un tenente della Julia: un uomo che sembra scarnificato, un spettro. “Ma lei” chiede al tenente “perché sta qui fuori con questo freddo e non entra nell’isba?” “Ero dentro – balbetta – ma mi hanno imposto di uscire perché sto morendo: così nessuno dovrà scomodarsi a trascinare fuori il mio cadavere”. Il giovane alpino è preso da un’ira sorda, feroce: entra nell’isba portando in braccio il tenente, che peserà trenta chili. Si fa largo tra le persone, urla, lo depone nel posto che gli sembra il migliore e grida: “È mio amico. Da questo momento, chi lo tocca avrà a che fare con me.” L’indomani il tenente muore. Nell’isba e non in strada, come un cane rognoso (pag.19).
I mesi passano. Il freddo, la fame, il tifo riducono quel ragazzone a uno scheletro di 37 chili. Lo spirito di sopravvivenza lo induce a raccogliere le ultime forze e a proporsi come aiuto nelle cucine del sanatorio in cui è stato mandato. Rubare la fondaglia delle marmitte e il bruciaticcio che resta sul fondo lo aiuta a stare in vita, fino alla primavera del 1944, quando viene spostato, con i compagni, in un altro campo in Siberia, per lavorare in una miniera.
Il comandante del campo li accoglie con una frase molto eloquente: “Qui sarà la vostra fine: chi entra non esce più”. E allora tanto vale tentare la fuga. Una notte, quando il buio è fitto e impenetrabile, striscio dalle latrine verso i reticolati… il cuore sembra scoppiarmi nel petto, ma non ho un attimo di esitazione. Scivolo come un serpente sotto l’ultimo filo di reticolato, sollevandolo con ogni delicatezza di quel tanto che basta e guadagnando pochi centimetri per volta…. Ogni più piccolo rumore mi fa gelare il sangue nelle vene… Eccomi fuori. Striscio ancora per centinaia di metri, adagio, quasi accarezzando la terra con il mio corpo. Ce l’ho fatta. Non ho dubbi sulla direzione da scegliere: la stazione. Poi si vedrà (pag.31).
Il giovane alpino sale su un treno. Appena scende viene subito catturato dai russi, che lo portano in un vicino campo di concentramento, dove resta, tra privazioni e patimenti, fino al 25 dicembre 1945, un giorno memorabile, che nessuno dei 1200 italiani del campo potrà mai dimenticare. È arrivato l’ordine di rimpatrio per tutti gli italiani. La partenza avviene alle ore 12.30 del 25 dicembre. Il treno macina chilometri e chilometri di steppa, neve e ghiaccio, la temperatura è di 45 – 50 gradi sottozero, nei vagoni niente di niente, senza riscaldamento, ci si scalda a fiato (pag.34).
Il viaggio di ritorno dura tre mesi. A Tarvisio città scendiamo tutti a terra, ci inginocchiamo per ringraziare il Padre Nostro che ci ha fatti tornare in Patria da quell’inferno di ghiaccio, desolazione e morte.
Arrivati a Udine veniamo circondati da una folla indescrivibile… chi di gioia per aver ritrovato il loro bravo alpino, chi di rassegnazione nel non vedere il proprio figlio, sposo, padre o fidanzato tra i rimpatriati; questi ultimi girano come ossessi tra noi elemosinando qualche briciola di notizia, anche se vaga, che possa ridare loro anche un piccolo barlume di speranza di poter rivedere un giorno il loro caro.
Dopo oltre 43 mesi di lontananza, il Calvario è finito, la vita ricomincia. Forse è un’era nuova, di pace fraterna tra i popoli (pag.35).
L’eco del suono di quella voce e di queste parole, che ho ascoltato tante volte, mi scende dritto al cuore. Quel ragazzo è diventato un uomo, si è sposato con Giulia, una donna forte e sempre sorridente, che ha amato di un lungo e vero amore. Ma quello che ha vissuto è rimasto inciso nel suo sguardo, nella profondità e nella tristezza dei suoi occhi. La sua testimonianza – così dura, così vera – deve insegnarci a ripudiare la guerra, senza se e senza ma, senza indugi, senza tentennamenti.
Altrimenti tutto ciò sarà successo invano.
Grazie del Suo insegnamento, Firmino Micheloni, Sergente dell’8º Reggimento Alpini della Divisone Julia. Ferito. Prigioniero. Croce al merito di guerra. Proposto per la medaglia d’argento al valore. Cavaliere Ufficiale al merito della Repubblica italiana. Commendatore.
Grazie, zio Firmino. E mandi (il bellissimo saluto friulano, che significa ti accompagni il Signore).
TITOLO: La ragazza della palude
AUTORE: Owens, Delia
EDITORE: Solferino
GENERE: Romanzo di formazione / thriller
PAGINE: 412
Barkley Cove, North Carolina,1952.
Kya Clark, una bambina di sei anni, vive in una baracca nella palude, tra canneti e canali. La palude è tutto ciò che ha: la madre, i fratelli, il padre, a uno a uno l’hanno lasciata sola, per andare incontro al proprio destino. Ma Kya non ha paura: la palude e le creature che la abitano proteggono e aiutano questa piccola bambina vestita di stracci a crescere e a trasformarsi in una splendida ragazza. La fama della sua bellezza ben presto oltrepassa i pantani e la fa conoscere, nella vicina città di Barkley Cove, come la “ragazza della palude”. Ma quando da un acquitrino affiora il corpo di Chase Andrews, con cui Kya ha avuto una storia d’amore, gli abitanti di Barkley Cove non hanno dubbi: la colpevole dell’omicidio non può essere che Kya…
Ciò che rende questo romanzo unico e particolare è proprio questo: la ricerca del colpevole e la storia dell’omicidio restano in secondo piano, perché i due veri protagonisti del romanzo sono la natura e Kya.
La natura, in queste pagine, è tutt’altro che un semplice sfondo: l’autrice, Delia Owens, è infatti una zoologa prestata alla letteratura (questo è il suo romanzo d’esordio), che condivide con il lettore non solo le sue conoscenze in materia di flora e di fauna (ma prima di sedersi dietro la ruota del timone notò un soffio color nocciola sul sedile e subito riconobbe la tenera piuma del petto di una femmina di nitticora: una creatura schiva, dalle lunghe zampe esili, detta anche airone notturno, che vive sola al riparo della palude, pag. 400), ma anche l’amore che prova per loro. Le descrizioni della palude, il luogo in cui “cantano i gamberi” (titolo originale del romanzo), sono così precise e ricche di dettagli da trasformarla in un vero e proprio personaggio, personificandola in una creatura che sembra prendersi cura di Kya con quell’affetto materno che le è stato negato: a volte sentiva rumori notturni che non conosceva o sobbalzava per lo scoppio di un fulmine troppo vicino, ma ogni volta che inciampava, la terra era lì ad accoglierla, finché alla fine, senza dire nulla, il dolore al cuore se ne andò, come acqua infiltrata nella sabbia. Sempre lì, ma molto, molto in fondo. Le mani appoggiate su quella terra umida e palpitante; e il pantano diventò sua madre (pagg. 46 – 47).
Questa natura così selvaggia si rivela dunque una madre amorevole per la piccola Kya, la cui crescita è narrata con l’attenzione e la precisione di un romanzo di formazione: Kya impara non solo a conoscere le diverse specie di uccelli e di insetti che abitano la palude, studiandone i comportamenti e ritraendone l’aspetto, ma anche a relazionarsi con le sole creature che la circondano, come i gabbiani, che nutre con amore e di cui diventa amica, sicura che loro non l’abbandoneranno, come hanno invece fatto gli umani (quando si presentò sull’arenile, gli uccelli arrivarono in un vortice e si tuffarono come una folata. Lei si inginocchiò e buttò il cibo sulla sabbia. I gabbiani le si fecero intorno e Kya sentì le piume sfiorarle le braccia e le gambe, buttò la testa all’indietro e sorrise con loro. Anche se le guance erano rigate di lacrime, pag. 166).
Le pagine dedicate alle riflessioni e ai pensieri di Kya sono particolarmente intense, capaci di esplorare le emozioni di una giovane creatura che impara a conoscere la rabbia, la solitudine, il disprezzo, ma anche l’amore e la generosità degli altri personaggi del romanzo: Chase, che si prende gioco dei suoi sentimenti, Tate, che le insegna a leggere e a scrivere, Mabel e Jumpin’, che diventano la famiglia che non ha mai avuto, forse perché, proprio come lei, conducono una vita ai margini della società, che li respinge in quanto neri (Kya prese a sussurrare e Mabel la strinse a sé, contro il petto; la strinse forte e la cullò. All’inizio Kya rimase rigida, non essendo abituata a ricevere abbracci, ma Mabel non si lasciò scoraggiare e alla fine la ragazzina si ammorbidì e si abbandonò su quei cuscini, pag. 142).
Il romanzo di formazione si intreccia dunque con il thriller: questa intersezione è resa possibile anche dalla felice scelta narrativa di fondere due piani temporali, quello degli anni della crescita di Kya e quello dell’anno 1969, in cui si collocano la scoperta del cadavere, le indagini per l’omicidio e il processo che vede Kya come imputata. La capacità di ritrarre la crescita di questa giovane ragazza, che studia la natura, gli uomini e la società che la circondano con lo stesso sguardo indagatore e attento, fa sì che il lettore, a differenza di quanto succede con i classici thriller, si appassioni alla storia di Kya e dimentichi il bisogno di scoprire il colpevole: ma quando questo succederà, ancora una volta non resterà deluso…
Un consiglio: alla lettura del romanzo può far seguito la visione del film, omonimo, che ne è stato tratto, perché la regia e gli sceneggiatori hanno rispettato l’articolazione del romanzo e scelto degli attori che rendono giustizia a questo piccolo capolavoro di narrativa moderna.
TITOLO: Diario di scuola
AUTORE: Pennac, Daniel
EDITORE: Feltrinelli
GENERE: Saggio / romanzo autobiografico
PAGINE: 241
Parigi, tra un passato da somaro e un presente da insegnante
Daniel Pennac – pseudonimo di Daniel Pennacchioni – è stato un pessimo studente, quello che noi insegnanti indichiamo con i termini scavezzacollo, sfaticato, fannullone o, più semplicemente, somaro. Il destino gli ha riservato il giusto castigo: diventare, a sua volta, un professore. In questo libro, a metà tra il saggio e il romanzo autobiografico, Pennac prova a riflettere sulla scuola dal suo vecchio punto di vista di somaro e da quello nuovo di docente, mescolando ricordi autobiografici e riflessioni pedagogiche, esperienze personali e vicende – divertenti o drammatiche – vissute dagli alunni che ha incontrato nei suoi lunghi venticinque anni d’insegnamento.
I temi affrontati sono dunque molteplici e si collocano in un orizzonte che comprende, oltre agli alunni e al loro rapporto con la scuola, il ruolo della famiglia, le istituzioni scolastiche, la società, i mezzi di comunicazione.
Pennac parte da una certezza: il primo a soffrire di essere un somaro è proprio l’alunno. Egli si ricorda bene lo sguardo preoccupato della madre e di coloro che erano pronti a scommettere sul suo inevitabile futuro fallimento. Per l’alunno diventa così normale fare i conti con la propria somaraggine e accettarla come parte integrante di sé… Sì, è la prerogativa dei somari, raccontarsi ininterrottamente la storia della loro somaraggine: faccio schifo, non ce la farò mai, non vale neanche la pena provarci, tanto lo so che vado male, ve l’avevo detto, la scuola non fa per me… La scuola appare loro un club molto esclusivo di cui si vietano da soli l’accesso. Con l’aiuto di alcuni professori, a volte (pag. 20).
Ma ci sono anche professori che salvano. È quello che è successo a Pennac: gli insegnanti che mi hanno salvato – e che hanno fatto di me un insegnante – non erano formati per questo. Non si sono preoccupati delle origini della mia infermità scolastica. Non hanno perso tempo a cercarne le cause e tanto meno a farmi la predica. Erano adulti di fronte ad adolescenti in pericolo. Hanno capito che occorreva agire tempestivamente. Si sono buttati. Non ce l’hanno fatta. Si sono buttati di nuovo, giorno dopo giorno, ancora e ancora… Alla fine mi hanno tirato fuori. E molti altri con me. Ci hanno letteralmente ripescati. Dobbiamo loro la vita. (pag. 33).
Degli eroi salvatori, dunque, questi poveri e spesso bistrattati professori. Pennac ora conosce bene quelle sensazioni che gli alunni nemmeno si immaginano che essi possano provare… Non sapevo, allora, che anche gli insegnanti ogni tanto la provano, questa sensazione di carcere a vita: rifriggere all’infinito le stesse lezioni davanti a classi intercambiabili, essere oppressi dal quotidiano fardello dei compiti da correggere… ignoravo che la ripetitività è la prima ragione addotta dagli insegnanti quando decidono di lasciare il lavoro (pag.48).
Il loro compito non è facile, perché ogni studente suona il suo strumento, non c’è niente da fare. La cosa difficile è conoscere bene i nostri musicisti e trovare l’armonia. Una buona classe non è un reggimento che marcia al passo, è un’orchestra che prova la stessa sinfonia. E se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la cosa importante è che lo facciano al momento giusto, il meglio possibile, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri, e che siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce all’insieme. Siccome il piacere dell’armonia li fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica, forse non in maniera brillante come il primo violino, ma conoscerà la stessa musica (pag. 107).
I genitori, in questo difficile compito, spesso non sono d’aiuto. Ci sono coloro che difendono i figli a spada tratta (e al giorno d’oggi – dobbiamo purtroppo aggiungere – anche in modo violento) e coloro che li crocifiggono: in una pagina Pennac si diverte ad elencare le molteplici tipologie di madri che ha incontrato, da quella a pezzi, logorata dalla deriva del figlio, a quella umiliata dai consigli delle amiche i cui figli invece vanno bene, da quella furibonda, convinta che il figlio sia da sempre la vittima innocente di una coalizione di insegnanti di tutte le materie, a quella che inveisce contro la società che si sgretola… (pag.41)
Eppure sarebbe fondamentale allearsi, insegnanti e genitori, per salvare il maggior numero possibile di studenti. Uno studente dallo scarso profitto non solo sopravvive a sé stesso, ma diventa anche vittima di Nonna Marketing e di altri mondi ancora. Sono una nullità. Orbene, nella società in cui viviamo un adolescente tenacemente convinto di essere una nullità – questo, almeno, l’esperienza vissuta ce lo ha insegnato – è una preda (pag. 65), che ricerca nell’apparenza, nei like, nel branco, nel riconoscimento da parte degli altri, quella forza che non ha saputo / voluto trovare nelle pagine dei libri.
Per salvare queste anime in difficoltà Pennac propone molteplici strategie: metodi di studio (per esempio, riscoprire la bellezza dell’imparare qualche testo a memoria – un esercizio inteso non come una sterile memorizzazione di contenuti, ma come una riflessione su quanto è stato scritto -), ma anche attività alternative, come la realizzazione di film, e persino la riscoperta della bellezza della matita, in una scuola completamente in balia della tecnologia, in cui si disimpara a scrivere già dalle scuole primarie e ci si affida a una tastiera che rende uguali tutte le grafie…
Salvare dal coma scolastico una sfilza di rondini sfracellate. Non sempre si riesce, a volte non si trova una strada, alcune non si ridestano, rimangono al tappeto oppure si rompono il collo contro il vetro successivo; costoro rimangono nella nostra coscienza, come le voragini di rimorso in cui riposano le rondini morte in fondo al nostro giardino, ma ogni volta ci proviamo, ci abbiamo provato. Sono i nostri studenti… (pag.241)
Questo è lo spirito che caratterizza ogni insegnante che abbia scelto il suo lavoro per passione. Questo è lo sforzo che ogni giorno compiono tantissimi insegnanti: nessuno degli studenti viene lasciato solo, perché c’è sempre qualcosa che ognuno sa fare e che gli piace fare, basta scoprire di che cosa si tratta. Il bravo insegnante è un artista nella trasmissione del suo sapere, un sapere così ben padroneggiato che ogni lezione può diventare una creazione, un momento unico e irripetibile.
Le pagine di Pennac, al di là di qualche momento autocelebrativo – così facile per la nostra categoria! – possono offrire utili spunti di riflessione a professori, alunni e genitori, per capire che c’è una medicina per il mal di scuola, ed è l’amore. L’amore per il proprio lavoro, l’amore per il sapere che viene regalato e la riconoscenza per chi si spende per educare i propri figli possono fare la differenza, consentendo di trasformare anche un somaro in un individuo capace di trovare la propria armonia nell’orchestra della vita…
E non c’è nulla di più bello, per un insegnante, di un alunno – bravissimo o somaro, non fa differenza – che ti porti per sempre nel suo cuore.
TITOLO: Il culo non esiste solo per andare di corpo
AUTORE: Rissa, Alvaro
EDITORE: Il Melangolo
GENERE: Antologia di letteratura greca e latina
PAGINE: 207
Grecia e Roma, dall’VIII secolo a. C. al V o VI secolo d. C.
Nelle nostre scuole ci sono professori davvero cattivi: essi hanno infatti deliberatamente deciso di non far conoscere ai loro alunni undici testi – incredibilmente belli – della letteratura greca e latina, che sono così rimasti patrimonio di pochi.
Quanto sarebbe bello leggere, accanto all’Iliade e all’Odissea, la Fantozziade, che ci è stata restituita dal Papiro di Ornitorinco 1262? Chi non vorrebbe conoscere l’epico scontro tra il povero Fantozzi e il magnanimo direttore?
Parli Lei per primo del film, dica un’opinione
che piaccia al mio animo, un assennato parere.
Se non obbedirà, io stesso La colpirò con forza,
e Lei giacerà più caro agli avvoltoi che ai colleghi.
Su, non rimandi il parlare, affinché io sappia
se Lei, pur ottuso, ha capito la Corazzata Potëmkin”.
Subito Fantozzi cambiò diecimila colori:
prima divenne bianco come fitti fiocchi di neve,
poi paonazzo come il buio caliginoso,
poi rosso sulle tempie, bluastro e nero sulla fronte.
Infine nefasta parola gli passò la chiostra dei denti:
«Ἡ Ποτιόγκις Ναῦς ἐστὶν χέζημα μέγιστον». (pagg. 36 – 37)
E che dire di una tragedia di Sofocle, I Presidi, anch’essa restituita da un papiro, in cui due presidi, Macco e Pappo, si confrontano in una disperata ricerca di alunni? I licei che non superano i 500 iscritti saranno, per volontà del ministro, accorpati. Il glorioso liceo Dante non raggiunge questo numero; deve perciò essere assorbito dal liceo Galileo, suo storico rivale. Di qui il casus belli. […] Macco e Pappo sovrastano la scena, la riempiono di sé, spingono il contrasto fino al punto di non ritorno. Ma alla fine, come spesso nell’arte sofoclea, una volontà imperscrutabile guida gli eventi verso un esito impreveduto, stemperando i conflitti in una superiore sintesi: tutto lascia credere che i due presidi, che hanno portato a distruzione le rispettive scuole, verranno duramente puniti. Invece il ministro li premia con un avanzamento di carriera. (pagg. 41 – 42)
I futuri avvocati non possono non affrontare la lettura del Sulla ricreazione di Lisia; gli amanti della filosofia troveranno pane per i loro denti nel dialogo Il Del Carlo o sul trimestre, in cui l’arte della maieutica viene esercitata per dibattere su un grave problema: in passato, quando Crono governava il tutto e dovunque si usava solo il quadrimestre (e anzi nessuno conosceva il trimestre neanche per sentito dire), neppure allora era facile per un professore svolgere il suo mestiere, da una parte fare lezione, dall’altra dare sufficienti voti a tutti, benché gli studenti fossero pochi e si comportassero bene. E ora che ciascuno di noi ha studenti innumerevoli, privi di ogni rispetto e moderazione, anzi ribelli, svogliati e cialtroni, e oltretutto ottusi e maldisposti, come potremmo ora, istituendo il trimestre, far fronte a tutti gli obblighi che prima si sbrigavano in due volte, e che adesso si devono sbrigare in tre? (pag.87)
Il povero Platone è il protagonista di un’altra tragedia, I ricercatori, in cui il filosofo, che si è reincarnato in un professore di Liceo, tenta la carriera universitaria. Fiducioso, Platone si iscrive alla prova, e qui un primo incredibile colpo di scena: il tema che esce dal sorteggio ha per oggetto la vita e opera di Platone! Nessuno potendo essere più ferrato di lui su tali argomenti, il Nostro consegna un lungo e dettagliatissimo elaborato: il trionfo sembra certo. E qui un nuovo colpo di scena: un altro candidato, che una voce suidiana definisce ὁ Ὑποβοηθούμενος («quello con l’aiutino») e ὁ Οἰκοσυμπλοκεύς (un hapax che potremmo tradurre «il candidato di casa»), e che nel papiro è indicato con la sigla PA (da integrare Ῥακκομανδηθείς secondo la ben nota proposta di Bruno Snell), avvicina il presidente di commissione e gli sussurra all’orecchio poche misteriose parole, ottenendo il massimo punteggio e la nomina immediata a ricercatore. Platone protesta, rivela la propria identità, chiede che il suo scritto venga almeno valutato. Ma la mossa dà cattivo esito: il presidente dimostra che il tema è scadente, e che le tesi sostenute da Platone su se stesso sono tutte sbagliate. (pag.103)
Molto si potrebbe ancora dire su altri capolavori, ma non possiamo non spendere una parola sui carmi oraziani, in particolare sull’Ode a Noemi (certamente un’antenata della splendida Naomi Campbell): nella quarta strofa di questa lunga ode saffica si trovano i sublimi versi che danno il titolo alla raccolta antologica proposta (pag. 157).
Chi, o Noemi, ha membra più belle
delle tue? Chi è più ben fatta di dorso,
di braccia, di viso, di fianchi, di labbra
e di tette?
Fra le modelle seminude tu più di tutte
incanti la platea, muovendo
il tuo corpo – elegante e senza difetti –
con armoniose torsioni.
Ma chi può negare che la miglior parte di te
è il culo? Quel culo che ti ritrovi
dimostra che l’universo
non è governato dal cieco caso.
Guarda le fulgide chiappe di Noemi,
e nega pure, se credi, che siano opera divina.
È evidente che il culo non esiste
solo per andare di corpo.
Ho trovato questo volume tra i miei regali di Natale: l’amica e collega che me lo ha donato è andata a colpo sicuro. Alvaro Rissa, infatti, saggista contemporaneo vivente, che ha studiato il ruolo del poeta nell’oltretomba, il ruolo dell’oltretomba nella poesia e il ruolo della letteratura nella gastronomia, non esiste: è lo pseudonimo scelto da Walter Lapini, docente di Letteratura greca all’Università di Genova e autore di numerose antologie per le scuole superiori. Ma questo volumetto non è un divertissement: ogni testo presentato – in lingua originale e con traduzione a fronte, una traduzione che strizza l’occhio a mostri sacri del calibro di Bignone, Manara Valgimigli, Calzecchi Onesti… – è stato composto in un greco e in un latino impeccabili, arricchiti di neologismi e, per quanto riguarda la poesia, addirittura nel pieno rispetto della metrica antica.
Un libro, dunque, che risulta fruibile da due categorie di lettori: i non classicisti, che ne coglieranno i contenuti divertenti, le caricature e le frecciate alla contemporaneità, al mondo della scuola e a quello delle università, e i classicisti, che aggiungeranno anche il compiacimento per il rispetto dei canoni letterari dei singoli generi (cito, a mero titolo di esempio, le forme particolari della lingua omerica, l’uso degli epiteti e lo stile formulare della Fantozziade), il metodo filologico, gli apparati critici e il fine tessuto di rimandi intra ed extra testo.
Il latino e il greco sono lingue complesse, che richiedono studio, ragionamento, impegno, costanza, fatica, dedizione e financo amore… parole desuete in una scuola che si allinea al “tutto e subito” imposto dalla moderna società. E allora ecco, quando va bene, il depotenziamento di queste lingue (cioè dei succedanei – letture di testi in lingua italiana e approccio generico o antropologico alla cultura e al pensiero – spacciati per studio delle lingue classiche) o, quando va male, la crociata contro queste materie inutili e sorpassate, che è ora di accantonare a favore di altre, immediatamente spendibili. Bisogna dunque avere il coraggio di dirlo a gran voce, come fa Rissa / Lapini con questo testo: il latino e il greco sono lingue vive, anzi vivissime, che hanno ancora molto da darci – struttura e solidità di pensiero vi sembrano poca cosa? – ma che lo possono fare solo se la scuola ha il coraggio di proporle con la serietà, il rigore e la disciplina che esse meritano e che insegnano, senza tentare ammodernamenti e attualizzazioni di cui non necessitano affatto, nel modo ampiamente dimostrato nella pungente prefazione, scritta in un didattichese che si commenta – tristemente – da sé. Come ha avuto modo di dire in un’intervista Rissa / Lapini, il latino e il greco sono discipline scomode, perché selettive, dei veri e propri antidoti contro la massificazione: proprio per questo esse sono – ora più che mai – sotto attacco.
TITOLO: La sposa normanna
AUTORE: Russo, Carla Maria
EDITORE: Piemme – Pickwick
GENERE: Romanzo storico
PAGINE: 236
Palermo, novembre 1185
Costanza d’Altavilla, monaca di clausura ormai da molti anni e ultima discendente della dinastia normanna che siede sul trono di Sicilia, viene improvvisamente convocata a corte, per ricevere un annuncio che non avrebbe mai immaginato di ascoltare… “Oggi stesso abbandonerete il convento, dispensata dal voto, con la piena assoluzione del vescovo. Per un lungo periodo vi è stato concesso di vivere la vita a modo vostro. Siatene soddisfatta. In questo momento siete necessaria allo stato e farete il vostro dovere fino in fondo. Abbiamo ricevuto una proposta di matrimonio che giudichiamo molto vantaggiosa. Presto sposerete Enrico di Svevia, figlio dell’imperatore Federico. Vi è affidato il compito di mettere al mondo l’erede al trono. Un giorno, vostro figlio diventerà il sovrano più potente d’Europa, perché riunirà nelle sue mani la corona dell’impero e quella del regno di Sicilia.” (pag. 21).
Comincia così la nuova vita di una donna bella, colta, raffinata, fragile ma allo stesso tempo determinata, che non ha nulla a che spartire con il diciannovenne rozzo, grezzo e malvagio che è stata costretta a sposare… Il primo impatto con Enrico di Svevia l’aveva delusa e umiliata. Non si era mai presentato a porgerle il benvenuto, né all’ingresso della città né sul sagrato della chiesa. Non l’aveva nemmeno accompagnata all’altare, come avrebbe imposto il cerimoniale concordato con fatica fra le cancellerie delle due parti. Nel corso della cerimonia, come durante il banchetto, non le aveva mai rivolto la parola, anzi, l’aveva trattata con sprezzante distacco (pag. 47). Eppure Costanza trova nella ricerca della maternità che le è stata imposta e che tarda ad arrivare – a trentatré anni sembra quasi impossibile! – l’unica sua vera ragione di vita.
Le parole che rivolge al piccolo Costantino, il giorno in cui si accorge della sua presenza dentro di lei, sono piene dell’amore che solo una madre può provare per il proprio figlio: “Costantino, mio amore, mia vita, mio preziosissimo tesoro… io sono la tua mamma. Ora so che esisti, che vivi dentro di me. Non temere, avrò cura di te. Ti stupirò con la mia forza. Tu stesso me la infonderai. Ti proteggerò nel mio grembo e ti porterò alla luce, ti amerò come nessuno al mondo ha mai amato un altro essere umano. Sarai fiero di me. Tu sei mio, solo mio, un Altavilla, come tua madre, tuo nonno Ruggero, il tuo antenato Roberto. Diventerai forte e bellissimo, nobile e generoso. Di te parlerà il mondo intero. Ti difenderò, impedirò a chiunque di farti del male” (pag. 93).
Costanza non sa che queste sue parole si riveleranno profetiche: il piccolo Costantino, destinato a diventare l’imperatore Federico II di Svevia, nasce infatti in un luogo in cui si intrecciano gli intrighi e i giochi di potere di nemici pericolosissimi, come Gualtieri di Palearia, inviato papale, e Markwald di Anweiler, capitano delle truppe mercenarie, per cui Costanza e il figlio rappresentano un grave pericolo. Costanza protegge fino all’ultimo istante di vita il suo agnello tra i lupi che abitano la corte, sostenuta dall’amore materno e dalla sua incrollabile fede. E quando non potrà più farlo, Costantino riceverà dalla sua forza e dal suo ricordo gli strumenti che gli permetteranno di avere la meglio sui suoi nemici e di diventare il grande uomo che la storia ricorda…
Una figura davvero affascinante, quella di Costanza, che non lasciò indifferente nemmeno Dante Alighieri, che la volle collocare nel III canto del Paradiso, nel cielo della Luna, dove si trovano le anime che sono venute meno ai voti per scelta altrui, ma che nel loro cuore sono rimaste fedeli a Dio. Dice Dante di lei per bocca di un’altra donna che fu strappata a forza dal convento, Piccarda Donati:
Sorella fu, e così le fu tolta
di capo l’ombra delle sacre bende.
Ma poi che pur al mondo fu rivolta
contra suo grado e contra buona usanza,
non fu dal vel del cor già mai disciolta.
Quest’è la luce de la gran Costanza
che del secondo vento di Soave
generò il terzo e l’ultima possanza.
Vediamone insieme la parafrasi.
Fu una monaca, e, come accadde a me, le fu tolta dal capo l’ombra del velo monacale. Ma dopo che fu di nuovo riportata nel mondo, contro la sua volontà e contro ogni norma onesta, nel suo cuore non fu mai libera dal velo monacale. Questa è la luce in cui brilla la grande Costanza, che dal secondo vento di Soave (una metafora per indicare un potere veloce e passeggero, poiché Enrico VI regnò per poco tempo) generò il terzo e ultimo imperatore della dinastia.
Anche in questi versi Costanza viene ritratta come una vittima innocente di complesse macchinazioni politiche: la luce della beatitudine che la circonda attesta la ricompensa divina per i torti subiti in terra, confermando la grandezza e la bellezza di questa figura femminile…
TITOLO: Fiorire d’inverno
AUTORE: Toffa, Nadia
EDITORE: Mondadori
GENERE: Romanzo autobiografico
PAGINE: 142
Brescia, primi anni ‘80
Nadia Toffa – la Nanetta, per i suoi famigliari – è la tipica bambina che si definisce argento vivo: a quattro anni mette per la prima volta gli sci e impara a scendere a spazzaneve da sola, a nove si medica da sé un profondo taglio che si è procurata su una gamba lanciandosi in bicicletta, a tutta velocità, lungo la rampa dei box, corre all’impazzata, salta, fa la ruota, segue un corso di ginnastica artistica… insomma, non sta mai ferma. E capisce, fin da piccola, alcune sacrosante verità: ho capito che mi sarebbe convenuto imparare a non mollare mai, perché gli altri mi potevano mollare in ogni momento (pag.34) e che se non ti butti finisce che resti al palo ad aspettare. È chiaro che buttarsi fa paura, per questo bisogna coltivare tanto coraggio, così tanto da riuscire a spaventare la paura (pag.46).
E allora Nadia si butta. La sua curiosità, la sua voglia di esserci, di conoscere il mondo, di fare esperienze, si concretizzano ben presto nelle collaborazioni con le televisioni locali, in cui comincia la sua gavetta: dopo quattro anni di Retebrescia, nel 2009 eccola approdare a Le Iene, il famoso programma di Italia1. Le sue inchieste diventano subito famose: le truffe ai danni del Servizio Sanitario Nazionale, la ludopatia, la pedofilia online, la prostituzione minorile, le donne rapite dall’Isis, e, soprattutto, lo smaltimento dei rifiuti tossici nella Terra dei fuochi e l’incontro con don Patriciello e i malati di cancro che vivono in quei territori. Ma la fama non la cambia: all’inizio ti dici: “Mi chiedono la foto perché sono quella della TV.” Poi senza nemmeno accorgertene ti ritrovi a pensare: “Mi chiedono la foto perché sono io” e l’autocelebrazione diventa la tua vita. Solo che quando ti cacciano la gente comincia a chiedere le foto a un altro, quello che ti ha sostituito. Bisogna vigilare di continuo perché questo scivolamento impercettibile non accada mai. L’ho fatto ogni giorno, perché non volevo cambiare, non volevo che il mio personaggio televisivo diventasse la mia vita, non volevo perdere la mia normalità e insieme a questa le relazioni con le persone a cui voglio bene (pag.97).
Ho sempre pensato che la vita fosse disporre sul tavolo nel miglior modo possibile le carte che il destino ti ha dato. Invece all’improvviso ne arriva una che spariglia le altre e la vita è proprio come ci si gioca quell’ultima carta (pag. 127). Il 1º dicembre 2017, mentre si trova a Trieste per un’inchiesta, all’improvviso il malore, che finisce sulle prime pagine di tutti i giornali. Nadia rassicura, ma qualche tempo dopo svela la verità proprio in apertura di una puntata de Le iene: ha un cancro (diretta com’è, non usa giri di parole), si è curata, sta bene. Nadia ha deciso di trasformare la sua malattia in un’esperienza pubblica, per aiutare chi, come lei, sta combattendo quella battaglia, convinta che la fragilità non sia qualcosa né da temere né di cui vergognarsi: la malattia, il dover stare a casa per così tanto tempo, l’avere bisogno di aiuto, mi hanno costretta a riprendere contatto con la mia parte più tenera e indifesa, quella più umana. Era come se mi fossi dimenticata che la fragilità non è una debolezza, ma è la condizione dell’essere umano ed è proprio lei che ci protegge, perché ci fa ascoltare quello che proviamo, quello che siamo, nel corpo e nel cuore (pag. 28).
I lunghi giorni delle cure le sottraggono il suo lavoro e le sue amate inchieste. Eppure, anche in questi momenti Nadia riesce a far emergere la sua positività: sono contenta di non poter decidere il corso degli eventi, perché perderei le scoperte che a volte si nascondono tra le ombre del destino. La vita di ciascuno di noi è costellata di eventi che in prima battuta sono stati delle delusioni, e invece poi hanno portato a una rinascita, a un nuovo equilibrio. Penso che ci sia un ordine più saggio, che governa il mondo e di cui spesso ignoriamo il senso, la prospettiva. Per questo ho una grande fiducia, mi alzo sempre col sorriso. Certo che preferisco il sole, ma quando ci sei in mezzo scopri che anche la neve ha la sua bellezza, e invece, se fosse stato per me, magari non l’avrei mai fatta cadere (pag.73).
Qualche giorno fa, il 10 giugno 2024, Nadia avrebbe compiuto 45 anni. Avrebbe, perché il 13 agosto 2019 ha perso la sua battaglia contro la malattia. Eppure nemmeno questo l’ha fermata: le pagine di questo libro, che si legge d’un fiato in poche ore, sono così piene di vita e di amore per la vita che ce la fanno sentire ancora viva e presente, con la sua voce squillante e la sua risata fragorosa. La sua storia, aiutandoci a ricordare che c’è un centro e una periferia, ci costringe a mettere in atto una rivoluzione copernicana, come la definisce lei stessa: quando vai alla radice e poi torni alla periferia, non potrai più confonderla con il centro. Sai qual è l’origine di ogni cosa e la sua relazione con il tutto, quindi i pesi si riequilibrano. Poi nel tempo la routine attenua la sensazione iniziale di distacco ma la consapevolezza acquisita non si cancella. Ora so che questa realtà è periferia, mentre prima pensavo che fosse la mia vita. È una rivoluzione copernicana (pag. 138).
Questo il senso ultimo del bellissimo titolo che lei stessa ha scelto per la sua autobiografia. Fiorire d’inverno vuol dire cogliere l’opportunità di fiorire quando tutti gli altri dormono, aspettando il tepore della primavera. Vuol dire non perdere tempo prezioso, facendo propria la lezione degli antichi, che non a caso Nadia ha voluto nel frontespizio del libro (pag.11), in cui si legge questo celebre distico tratto dalle Odi del poeta latino Orazio:
Dum loquimur, fugerit invida aetas:
carpe diem, quam minimum credula postero.
Mentre parliamo, il tempo invidioso sarà fuggito:
cogli l’attimo e confida il meno possibile nel domani.
TITOLO: La migliore offerta
AUTORE: Tornatore, Giuseppe
EDITORE: Sellerio
GENERE: Romanzo d’amore / romanzo giallo
PAGINE: 93
Un’imprecisata città del centro Europa, in epoca contemporanea
L’esistenza di un film deriva spesso da un racconto orale. E non solo perché oggi si legge sempre di meno. Anche in passato le cose andavano allo stesso modo (pag. 9). Con queste parole il regista Giuseppe Tornatore comincia la sua prefazione a quello che, secondo l’unità di misura delle pagine fissata da Edgar Allan Poe, può essere definito un “romanzo breve”. È lo stesso Tornatore a spiegarci la sua genesi sempre nelle pagine che precedono l’inizio del racconto.
Nel mio archivio di annotazioni giaceva già dalla metà degli anni Ottanta, tra spunti e soggetti e altre suggestioni, la figura di una ragazza molto introversa, che in seguito a una serie di gravi problemi psicologici viveva reclusa in casa per paura di camminare lungo le strade e mischiarsi in mezzo agli altri (pag.10). Nasce così il personaggio di Claire Ibbetson, una misteriosa donna malata di agorafobia (la paura degli spazi aperti), che le impedisce di uscire dalla sua stanza, situata nell’antica dimora di famiglia.
Continua Tornatore: Un giorno […] mi sono imbattuto in un altro personaggio smarrito nel purgatorio di quella montagna d’appunti che mi porto dietro, anch’esso in attesa di essere coinvolto in un contesto narrativo che gli si confacesse. Si trattava di una figura maschile. Un uomo impegnato in un mondo che mi ha sempre attratto, quello dell’arte e dell’antiquariato (pag.10). È così che vede la luce il sessantenne Virgil Oldman, un rinomato e stimato battitore d’aste che sa ottenere sempre la miglior offerta che dà il titolo al romanzo. Virgil vive da solo, ossessionato dall’igiene (non tocca nulla – tranne le opere d’arte – senza guanti), completamente assorbito dal suo lavoro e dalla sua preziosa collezione di ritratti femminili, che custodisce in una stanza blindata della lussuosa dimora in cui abita: contemplare i volti di quelle 279 donne che lo guardano in modo enigmatico e amoroso è il suo unico piacere.
Benché – prosegue Tornatore – i due personaggi non avessero alcuna relazione, essendo nati non solo in tempi diversi ma da attrattive e interessi totalmente dissimili, cominciai a farli interagire tra loro, seguendo un procedimento analogo a ciò che nel linguaggio musicale si chiama “contrappunto doppio”. Cioè inscrivere una melodia in un’altra, far convivere due temi diversi in una composizione ulteriore che finisce per esaltare in una nuova forma le potenzialità espressive ed armoniche dei singoli disegni melodici. […] E una volta innestate l’una nell’altra, la vicenda della ragazza agorafobica e quella del battitore d’aste hanno miracolosamente originato la completezza narrativa che da anni inseguivo e non trovavo (pag. 12).
Due anime solitarie, dunque, che s’incontrano per motivi di lavoro: Virgil viene infatti incaricato telefonicamente da Claire di provvedere alla vendita di tutto ciò che si trova nella sua villa. Il loro rapporto cresce e si sviluppa da lontano: prima per telefono e poi dietro una porta, attraverso la quale la donna comunica con lui. Il cuore di Virgil si lascia sempre più sedurre e incatenare da quella voce così fragile, intensa e sofferente, che gli crea intorno una sorta di ragnatela, dalla quale finisce per essere avvolto. Ben presto Virgil comincia così ad avvertire un sentimento che sembra essere molto vicino a quell’amore che egli non ha mai provato, se non per l’arte, e che lo costringe a fare i conti con la vita vera, pericolosamente intrecciata proprio all’arte. La speranza, per il povero Virgil, è che siano vere le parole del suo amico Robert: in ogni falso si nasconde sempre qualcosa di autentico (pag. 85): di più non si può dire, perché questa è una vicenda molto semplice e scarna, più ricca certamente in quel suo sottotesto che soltanto il finale, nel rispetto della tradizione del racconto giallo, ha il compito di svelare (pag. 13).
Una volta terminata la lettura del romanzo non si può non vederne la splendida realizzazione filmica, che ha anche il pregio di esaltare l’arte in ogni sua forma (i quadri, le statue, gli abiti, gli orologi, gli automi…): come scrive lo stesso Tornatore, il suo è un film sull’arte intesa come sublimazione dell’amore, ma anche un film sull’amore inteso come frutto dell’arte (pag. 13). E il vero senso di quest’ultima affermazione si svelerà completamente solo al termine della lettura o della visione del film…
TITOLO: Il castello di Otranto
AUTORE: Walpole, Horace
EDITORE: Crescere edizioni
GENERE: Romanzo gotico
PAGINE: 125
Otranto, presumibilmente tra il 1095, anno della prima crociata, e il 1243, data dell’ultima (o non molto più tardi)
Un usurpatore ha avvelenato Alfonso, il legittimo principe di Otranto, e ne ha consegnato il titolo al nipote Manfredi, un uomo duro e spietato, ma in realtà non così cattivo come dà a vedere: Manfredi, infatti, non era uno di quei tiranni sanguinari che godono a infierire senza essere stati provocati. I casi della vita avevano reso più duro il suo carattere, che di natura era comprensivo, e le sue virtù erano pronte a emergere se la furia non gli ottenebrava la mente (pag. 33).
Questa furia nasce dalla consapevolezza che il suo potere è sotto l’oscura minaccia di una profezia di San Nicola, che grava da secoli sulla casata: essa dice che “il castello e la signoria di Otranto sfuggiranno all’attuale famiglia quando il vero possessore sarà divenuto troppo grande per abitarvi” (pag. 17). Nessuno riesce a capire che cosa significhi questa maledizione: essa pare però essere sul punto di avverarsi fin dalle prime pagine del romanzo, quando l’unico figlio maschio di Manfredi, Corrado, un quindicenne brutto e malaticcio che non faceva presagire nulla di buono (pag. 17), viene ucciso da un elmo gigante – identico a quello, di dimensioni normali, che si trova sulla statua di Alfonso – che piomba su di lui poco prima delle sue nozze con la dolce Isabella, figlia del marchese di Vicenza.
Dopo questo tragico e misterioso evento Manfredi comprende che il suo destino sta per compiersi: per questo decide di avere subito un altro figlio maschio ripudiando la moglie Ippolita, fedele e devota, e sposando la giovane Isabella, che, venuta a conoscenza del suo vergognoso piano, fugge disperata nei lugubri sotterranei del castello, il cui piano inferiore era formato da un intricato complesso di corridoi, e non era facile per una persona in preda all’ansia trovare la porta della galleria. In quei sotterranei c’era un silenzio impressionante, a parte qualche raro soffio di vento che muoveva le porte davanti a cui passava e che ne faceva cigolare i cardini arrugginiti creando un rumore spettrale nell’interminabile labirinto di tenebre. Ogni minimo fruscio scatenava in lei nuove paure, ma ancor più temeva di udire la voce rabbiosa di Manfredi che incitava i servi ad andarle dietro (pag. 27).
In questo castello stregato, teatro di apparizioni, prodigi inspiegabili e loschi intrighi non possono mancare gli aiutanti della povera fanciulla perseguitata. Il primo è Teodoro, un contadino dal cuore puro e dai nobili ideali, che scopre molto, del suo passato, durante lo svolgimento della vicenda che lo vede – suo malgrado – protagonista. La seconda è Matilda, la figlia di Manfredi, una ragazza molto bella di diciotto anni, che Isabella considera una sorella; Matilda ama incondizionatamente i genitori, al punto da perdonare il padre per l’affetto che è incapace di dare a lei, ma non per quello che nega anche alla madre (il suo cuore è sempre stato lontano da me… ma è sempre mio padre e non mi devo lamentare. No, anche se il cielo mi nega il cuore di mio padre, ricompensa fin troppo i miei scarsi meriti con l’affetto di mia madre. Oh, cara madre mia! Sì, Bianca, è per questo che soffro delle cattiverie di Manfredi. Posso sopportare a capo chino la sua durezza nei miei confronti, però mi ferisce il cuore la sua severità senza senso verso di lei. Pag. 42).
Il castello di Otranto, pubblicato nel 1764, inaugura il genere del cosiddetto romanzo gotico. Questo aggettivo – presente nel sottotitolo – all’epoca della stesura del romanzo era inteso come un sinonimo di medioevale: tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento il Medioevo barbarico descritto dalla storiografia illuministica aveva iniziato a esercitare un fascino particolarmente intenso, finendo per costituire lo sfondo ideale per storie a tinte forti, capaci di suscitare nel lettore il sottile piacere della paura. In questo romanzo sono pertanto chiaramente identificabili tutti i motivi tipici del racconto gotico (la cui eredità sarà raccolta dal moderno genere horror): vi troviamo, infatti, l’innocente vittima femminile sottomessa a una perversa autorità maschile, l’irruzione improvvisa dell’elemento sovrannaturale, cupe atmosfere da incubo, passaggi segreti, eventi prodigiosi (spettri, quadri animati, l’immancabile spada magica…), la tipizzazione dei personaggi in buoni e cattivi, l’importanza della difesa della virtù femminile, maledizioni e profezie…
Questo romanzo è davvero molto lontano da noi: cavalieri dal nobile cuore e dalla morale specchiata, cattivi usurpatori del potere altrui, giovani fanciulle disposte a tutto pur di difendere la propria virtù, mogli e figlie devote a Dio (quasi in odore di santità!) e docilmente sottomesse agli uomini, servitori ridicoli e cameriere pettegole sono però capaci di portarci in un mondo che prima rapisce con una trama scorrevole e veloce come la fuga di Isabella, e poi spinge a fermarsi a riflettere, per esempio sui numerosi simboli che si celano nella narrazione (il passaggio dalle stanze del castello ai sotterranei si presenta quasi come una discesa nella profondità del proprio animo, l’elmo gigante simboleggia la giustizia di Dio che punisce l’usurpatore, il contrasto luce – ombra riflette il conflitto Bene – Male…). Quello che l’autore ci chiede, insomma, è di seguirlo nel vortice della sua narrazione, per esplorare la fragilità umana e la lotta contro le forze oscure che allontanano l’uomo dal Bene: in questo modo il lettore potrà vedere che i valori antichi danno la garanzia che il Bene riuscirà sempre a trionfare, anche contro un Male potente e disposto a tutto. Non è un caso che nella prima Prefazione al romanzo l’autore abbia finto – con un espediente di manzoniana memoria – di ritrovare nella biblioteca di un’antica famiglia cattolica del nord dell’Inghilterra un manoscritto che raccontava questa storia: una trovata con cui egli attribuisce una patente di credibilità alla vicenda narrata, in modo che la religiosità che vi regna, le lezioni di virtù che vi sono impartite e la rigorosa purezza dei sentimenti mettano l’opera al riparo dalle critiche a cui i romanzi sono fin troppo spesso soggetti (pag.7).
Tuffiamoci, allora, in questo mondo lontano, perché, come scrisse l’autore in una delle lettere del suo Epistolario, lungi dall’essere invecchiato abbastanza da questionare sulla loro vacuità, sono pronto a credere che non ci sia saggezza più grande che di scambiare ciò che chiamiamo la realtà della vita con i sogni. Antichi castelli, antichi quadri, antiche storie e le chiacchiere degli anziani ci riportano a vivere in secoli passati che non possono deluderci.
TITOLO: I miei giorni alla libreria Morisaki
AUTORE: Yagisawa, Satoshi
EDITORE: Feltrinelli
GENERE: Romanzo di formazione
PAGINE: 144
Jinbocho, da inizio estate a primavera
Nel quartiere storico di Jinbocho, a Tokyo, i negozi sono solo librerie: esso, nato verso la fine del 1800, è infatti il più grande quartiere librario del mondo, un parco giochi per gli amanti dei libri, che sono esposti a migliaia nelle vetrine, nuovi oppure usati. La protagonista del romanzo, la venticinquenne Takako, arriva nel quartiere in seguito a una forte delusione d’amore, che la spinge a licenziarsi e a cercare un modo per cambiare completamente vita, dopo aver provato a ingannare il suo male di vivere dormendo per ore e ore. Così, anche se non ama né la lettura né i libri, accoglie l’invito dello zio Satoru di andare a stare da lui e di occuparsi per qualche ora al giorno della sua libreria, che si trova all’angolo di una strada piena di librerie dell’usato. È piccola, vecchia, e non sembra che gli affari vadano troppo bene. Di clienti se ne vedono pochi. Tratta una varietà piuttosto limitata di libri e, a meno di essere degli esperti appassionati, è difficile che la si conosca. Eppure c’è chi ama questo posto (pag. 140).
Lo zio Satoru – capelli spettinati, montatura spessa degli occhiali, corporatura esile di un adolescente. Camicia a quadri a mezza manica, pantaloni spiegazzati e sandali ai piedi (pag. 20) – è un sognatore amante dei libri, che da decenni gestisce la libreria di famiglia non come un negozio con cui fare affari, ma come un luogo in cui rifugiarsi e trovare riparo dalle sofferenze: anche lui, infatti, ha il cuore spezzato, poiché è stato improvvisamente abbandonato dalla moglie Momoko, che ha poi fatto perdere le sue tracce.
Satoru accoglie la nipote con grande cordialità: Takako, però, è a disagio in un posto che non sente suo. Zio e nipote sembrano addirittura arrivare da due mondi diversi: Takako, appena entrata nella libreria, avverte un fortissimo odore di muffa. Mi sfuggì detto ad alta voce, lui mi corresse in tono scherzoso: “Dovresti dire che odora come le mattine dopo la pioggia” (pag. 21).
Ma poi accade l’imprevedibile: una notte, in cui il sonno tarda ad arrivare, Takako prende in mano un libro ed ecco la magia… Pensavo che mi sarei annoiata, e quindi addormentata, nell’arco di pochi minuti. E invece cosa mi stava capitando? Un’ora dopo ero completamente rapita dal libro. Lo stile era difficile, pieno di parole complicate, ma parlava della psiche di un personaggio instabile, che suscitò in me un forte interesse (pag. 41) L’espressione “mi ha preso” non rendeva neanche lontanamente l’idea del subbuglio interiore che quel libro aveva provocato in me (pag. 42).
Da questo momento Takako comincia a guardare i libri che la circondano in modo completamente diverso: le loro pagine, le sottolineature e gli appunti di chi li ha letti, i fiori secchi lasciati come segnalibro iniziano a esercitare su di lei un fascino misterioso, prepotente, che la cambia dentro, costringendola ad aprirsi al mondo dei clienti della libreria, a chi vive nel quartiere, alla zia, che ricompare improvvisamente e con cui intraprende addirittura un viaggio. Anche per Takako la libreria Morisaki diventa ciò che è per lo zio Satoru: il posto in cui si è certi di non stare mentendo al proprio cuore, il luogo in cui riprendere fiato quando la vita ci mette alla prova…
La storia raccontata da questo romanzo è veramente semplice, a tratti quasi prevedibile e banale. Eppure esso è diventato un best seller, ha vinto un prestigioso premio letterario in Giappone, è stato tradotto in sedici Paesi. Mi sono domandata il motivo di questo straordinario successo – oltretutto di un’opera prima! – e ho trovato la risposta proprio nel messaggio che si coglie tra le pagine di questo libro che parla di libri e di librerie. Esso, infatti, lascia intendere che nella vita contano poche e semplici cose: gli affetti, i rapporti umani e la capacità di farsi rapire dalle parole che altri hanno scritto, parole che ci invitano, raccontandoci altre vite, a guardare con più attenzione la nostra. I libri sono la chiave per conoscere altri luoghi, altre esperienze, altre speranze, altri dolori… i libri ci cambiano, ci fanno crescere, ci mettono alla prova, ci fanno chiudere con il passato e aprirci al futuro, proprio come succede alla protagonista. Il tempo per leggere – ha detto Daniel Pennac – come il tempo per amare, dilata il tempo per vivere. È proprio questa la preziosa consapevolezza a cui giunge Takako, quando ripensa ai giorni trascorsi nella libreria: il ricordo di quelle giornate è ormai parte di me perché è proprio lì che la mia vita, la mia vera vita, è cominciata. Senza quell’esperienza tutto sarebbe stato molto più scialbo, banale, piatto (pag. 11).
TITOLO: Storia di una ladra di libri
AUTORE: Zusak, Markus
EDITORE: Frassinelli
GENERE: Romanzo storico
PAGINE: 562
Germania, 1939.
Liesel è una bambina tedesca di nove anni. Viaggia con la madre e il fratellino su un treno che li porterà a Monaco, dalla famiglia adottiva che si prenderà cura di loro, perché la madre – sola – non è più in grado di accudirli. Ma il fratellino è troppo affamato e debilitato: il suo percorso terreno termina proprio durante questo viaggio. E così Liesel incontra per la prima volta non solo la Morte, ma anche i libri, che le cambieranno la vita: sarà infatti proprio il casuale ritrovamento di un piccolo libro (il Manuale del necroforo, caduto nella neve a uno dei becchini chiamati a seppellire il fratello) a trasformarla in una ladra di libri. Solo i libri – e le loro parole – le permetteranno di sopravvivere all’orrore della Germania nazista, perché solo i libri – e le loro parole – sanno donare, a chi li ama, i loro frutti migliori, arrivando a salvare la vita e l’anima delle persone…
Ma questo romanzo non tesse solo le lodi delle parole. Sono state proprio le parole, diventate propaganda, a dare la forza e il potere a Hitler e a trascinare il suo popolo in una pulizia etnica senza senso: lo descrive in modo chiaro uno dei principali personaggi di questo romanzo, l’ebreo Max, che disegna per Liesel, nei suoi lunghi giorni senza sole, nascosto in una cantina, una storia strana, ma purtroppo vera: Sì, il Führer decise di dominare il mondo con le parole. […] Il suo primo piano d’attacco consisteva nel seminare parole nel maggior numero possibile di luoghi del suo Paese. Le seminò giorno e notte, e le coltivò. Le guardò crescere, finché, alla fine, in tutta la Germania si potevano vedere grandi foreste di parole… Era una nazione di pensieri coltivati (pag.457).
Non tutti i tedeschi, però, soccombono al potere delle cattive parole. Hans, il padre adottivo di Liesel, è diverso da loro. Liesel nota subito la singolarità dei suoi occhi che sono fatti di bontà e d’argento. Di un argento soffice, liquido (pag. 34). Proprio dal suo nuovo papà Liesel apprende un’importante verità: le parole possono salvare o condannare, essere piene d’amore o di odio. Dipende da come le si usa: Ho odiato le parole e le ho amate, scrive Liesel. Spero che siano tutte giuste (pag.541). Che Liesel abbia imparato a farne buon uso lo testimonia ancora Max, quando scrive di lei che I MIGLIORI erano quelli che comprendevano l’autentico potere delle parole. Riuscivano ad arrampicarsi sugli alberi più alti. Tra gli scuotitori di parole c’era una ragazzina minuta ed esile. Era considerata la migliore della sua regione, perché si rendeva conto di quanto impotente potesse essere una persona SENZA parole. Era affamata di parole (pag. 458).
Una delle particolarità di questo romanzo (la struttura narrativa frammentata, la presenza di parti fumettistiche, i titoli interni ai capitoli, le frequenti anticipazioni…) è senza dubbio il narratore, che, come si comprende sin dalle prime pagine, è la Morte. È ben diversa da come viene presentata di solito ed è lei stessa a dirlo al lettore: Non possiedo una falce. Indosso una veste nera con cappuccio solo quando fa freddo. Non ho quel viso da teschio che sembrate divertirvi ad appiopparmi. Vuoi sapere qual è il mio vero aspetto? Mentre proseguo il racconto, cerca uno specchio (pag.315).
Triste, malinconica, solitaria, la Morte fornisce la chiave di lettura di questa vicenda, rammaricandosi per tutto quello che ha dovuto vedere in quegli anni. È stato troppo anche per lei, che scende sulla terra sforzandosi di concentrarsi sui colori, perché pensare a quello che succede le dà troppo dolore: Devi sapere che, a dispetto di tutti i colori che sfiorano o si avvinghiano a ciò che vedo in questo mondo, spesso quando un uomo muore vedo, soltanto per un attimo, un’eclissi. Ne ho viste a milioni. Ho visto più eclissi di quante vorrei ricordare (pag.11).
Le domande più forti e le osservazioni più ricche di significato di questo romanzo emergono proprio dal continuo colloquio che la Morte crea con il lettore: se da un lato la Morte riconosce agli uomini grandi qualità (Mi meraviglia sempre la forza degli esseri umani, che riescono a rialzarsi, seppure barcollando, persino quando fiumi di lacrime inondano i loro volti pag. 549) dall’altro resta stupita per la loro stupidità: Nel corso degli anni ho visto tanti giovani che credono di correre gli uni contro gli altri. Non è così. È verso di me che corrono (pag. 180).
La storia di Liesel è il resoconto di una vita ricostruita in un piccolo libro nero, scritta in uno scantinato mentre fuori piovono bombe: essa affida al lettore un’intensa vicenda che appassiona e commuove, che parla di morte ma anche di amore, di parole e di gesti, di uomini veri e di comparse… ma soprattutto non è che una della miriade di storie che la Morte porta con sé, ognuna a suo modo straordinaria. Ciascuna di loro rappresenta un tentativo – un faticoso tentativo – di dimostrare che la vostra esistenza di uomini vale la pena di essere vissuta (pag.14).
Ultime notizie dalla SOFISTERIA
Gennaio 2026 in Sofisteria
CANALE YOUTUBE Le curiosità della Sofisteria. GRECOLe curiosità della Sofisteria....
Dicembre 2025 in Sofisteria
CANALE YOUTUBE Le curiosità della Sofisteria. GrecoLe curiosità della Sofisteria....
Buone Feste dalla Sofisteria!
Cari amici della Sofisteria, sono molto contenta di festeggiare il terzo Natale insieme...

GRAMMATICA ITALIANA

SCUOLA DI SCRITTURA

GRAMMATICA LATINA

GRAMMATICA GRECA

LETTERATURA ITALIANA

LECTURA DANTIS

LETTERATURA LATINA