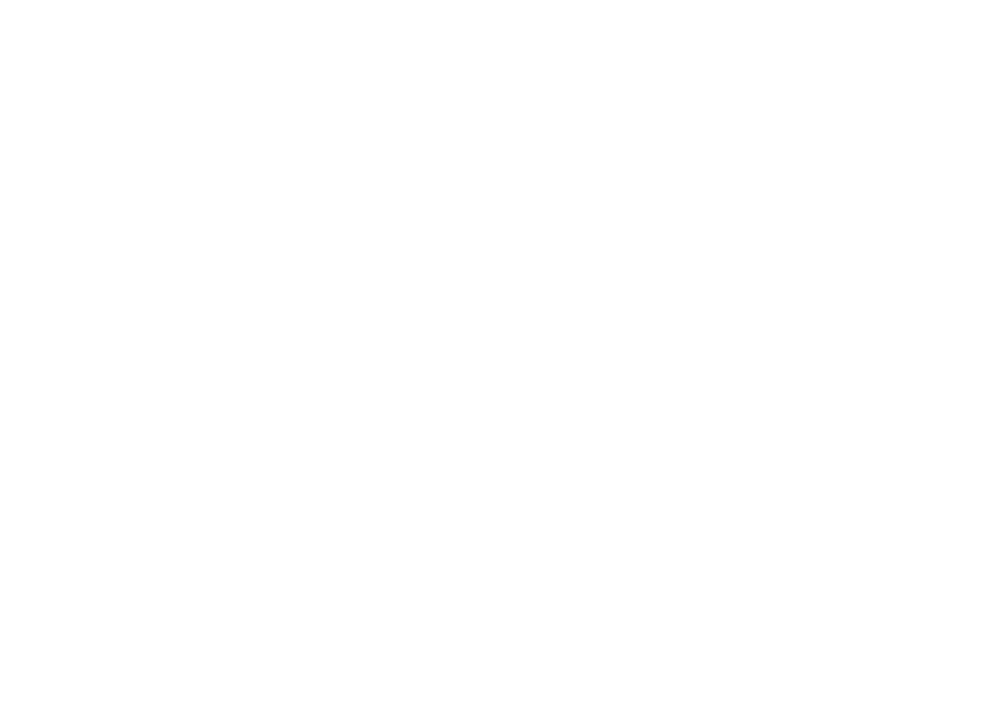Palindromo
in PAROLE DELLA LETTERATURA \ LESSICO \ GRAMMATICA ITALIANA
Il termine palindromo – attestato nell’italiano dal 1695, nella forma palindromon – deriva dal greco παλίνδρομος (palíndromos), un vocabolo composto dall’avverbio πάλιν (pálin) “all’indietro” e dal sostantivo δρόμος (drómos) “corsa”.
Viene usato per indicare una parola, una frase o una cifra che, letta in senso inverso, mantiene immutato il suo significato. È il caso, per esempio, delle parole osso, ossesso, aerea…, delle frasi (alcune decisamente ridicole) I topi non avevano nipoti, Anna di sera se c’è Cesare si danna, Amo ridere di Roma, E poi Martina lavava l’anitra miope (quest’ultima è il titolo di una raccolta di 181 frasi palindrome di Marco Buratti, tra cui spicca la meravigliosa considerazione palindroma su un ballerino ottuagenario, che Allorché balla… Beh. Crolla) … e dei numeri 121, 1331…
Esistono anche i cosiddetti palindromi sillabici, costituiti da parole come Ma – rem – ma o po – li – po, a cui si riconducono anche date come 24/4/24. I palindromi con le date (per esempio 02 /02 /2020) sono infatti piuttosto rari: basti pensare che essi sono solo 366 in diecimila anni e che per il prossimo bisognerà attendere il 29 /02 /2092!
Il termine palindromo viene usato in letteratura per indicare dei versi che rimangono identici anche se letti al contrario, come accade in un celebre esametro secondo alcuni attribuibile a Virgilio:
In girum imus nocte, ecce et consumimur igni
Esso può essere tradotto con Andiamo in giro di notte, ed ecco siamo consumati dal fuoco e potrebbe essere riferito alle farfalle notturne, che, attirate dal fuoco nel buio della notte, finiscono per bruciarsi.
Questo termine è usato anche nell’enigmistica per identificare un gioco che consiste nel trovare delle parole che, lette da destra a sinistra e da sinistra a destra, mantengono lo stesso significato, come quelle già citate, oppure ne acquisiscono uno diverso, come accade a Italia, che diventa ai lati, ad Angela, che si trasforma in a legna, a Isabella, che diviene alle basi…
L’inventore dei palindromi fu probabilmente il poeta greco Sotade, vissuto ad Alessandria d’Egitto nel III secolo a.C.; il palindromo più famoso è il quadrato del Sator, un’iscrizione latina in forma di quadrato composta da cinque parole
SATOR
AREPO
TENET
OPERA
ROTAS
Come si può vedere dall’immagine, queste parole possono essere lette da sinistra a destra e viceversa. Leggendole in orizzontale prima dall’alto verso il basso procedendo da sinistra verso destra e poi dal basso verso l’alto, procedendo da destra verso sinistra, si ottiene una frase palindroma (Sator arepo tenet opera rotas). Non solo. La stessa frase può essere ottenuta anche leggendo in verticale, prima dall’alto verso il basso procedendo da sinistra a destra e poi dal basso verso l’alto, procedendo da destra a sinistra. La parola tenet, perfettamente palindroma, forma inoltre una croce proprio al centro del quadrato.
Il significato di questa frase palindroma potrebbe essere Il seminatore con la roncola guida con cura le ruote, ma non tutti gli studiosi concordano su questa interpretazione, sia per il valore che è possibile attribuire ai singoli vocaboli (per esempio Arepo, attestato solo in quest’iscrizione, da alcuni è interpretato anche come un nome proprio) sia per l’ordine di lettura delle singole parole, che potrebbero consentire anche una lettura bustrofedica (un termine greco che può essere tradotto “alla maniera dei buoi quando arano”: questo significa leggere cambiando direzione ad ogni riga – la prima da sinistra a destra, la seconda da destra a sinistra e così via… – seguendo appunto l’andamento dei buoi che arano un campo).
Sono stati rinvenuti moltissimi esemplari di questa iscrizione sparsi in tutta Europa, forse perché essa era ritenuta una formula magica: quest’ipotesi è supportata dal fatto che uno dei più antichi esemplari ritrovati, inciso su una colonna di una casa di Pompei, era arricchito da strani segni e simboli.
La Sofisteria
LESSICO in GRAMMATICA ITALIANA

GRAMMATICA ITALIANA

SCUOLA DI SCRITTURA

GRAMMATICA LATINA

GRAMMATICA GRECA

LETTERATURA ITALIANA

LECTURA DANTIS

LETTERATURA LATINA